U.S. Hard Rock
Underground - Introduzione
La genesi di un "genere"
Nel 1967, quando il Rock scoprì il triangolo, la musica non fu più la
stessa.
I Cream e la Jimi Hendrix Experience, forti di un
tasso virtuosistico mai sentito prima, spazzarono via in un sol colpo il
flebile Folk-Rock di Los Angeles, lo sballato acido di San Francisco e quanto
rimaneva del Merseybeat, del Surf e della British Invasion. I Beatles, divinità
talmente enormi da non riuscire nemmeno a suonare dal vivo (per chi se la beve
ancora…) furono rasi al suolo e costretti a sciogliersi con una Fender puntata
alla tempia.
L’America, notoriamente un mercato troppo enorme per votarsi
interamente ad una sola corrente, fu comunque elettrizzata da quel formato
compatto di Power-Trio britannico (Hendrix dovette emigrare a Londra per
costruirsi una carriera…). Ma se Clapton ed il mezzosangue Cherokee erano
modelli di improba imitazione per teenager brufolosi alle prime armi, ingrifati
di rock e chitarra elettrica, fu un oscuro gruppo di bikers di Frisco a trovare
una soluzione e stabilire una specie di nuovo “canone”. I Blue Cheer, e specialmente l’inetto chitarrista Leigh Stephens,
capirono che non importava poi essere virtuosi spaziali quando chiunque può
ruotare la manopola del volume verso destra. Verso destra finché ce n’è… Il
volume, e il feedback caotico (sua immediata conseguenza) furono una chiave di
volta, una scorciatoia che poteva trasformare qualunque chitarra elettrica in
una roboante e futuristica arma di distruzione di massa. Ma ancora non bastava
a stabilire una nuova estetica. La risposta questa volta venne da oltreoceano…
I Cream dopotutto erano un supergruppo di partigiani blues a tempo
determinato, tanto immersi nel business da non riuscire a creare un culto di
fans fondato sull’empatia e il feeling. Hendrix era il manifesto di ogni
megaraduno del 1970 ma il suo stile era talmente unico e inarrivabile che
nessuno sarebbe più riuscito a suonare come lui e il solo tentativo di
replicare i suoi assoli fiammeggianti avrebbe frustrato migliaia di quindicenni
da lì al 1975. I Blue Cheer, ahimè, non se li filava nessuno.
Fu allora che su questo triplo triangolo si inserì, come potente
catalizzatore, il quartetto britannico dei Nuovi Yardbirds, o Led Zeppelin se
preferite, reietti in patria e mendicanti fortuna in USA; con i primi quattro
tour, tra il 1968 e il 1969, aggiunsero a virtuosismo, volume e feedback una spropositata carica sessuale
maschilista ed una batteria semplice ma potentissima. Il gioco era fatto.
Nel loro solco si stabilì, tra gli altri, quello che sarebbe subito
divenuto il gruppo-paradigma dell’Hard-Rock made in USA: i Grand Funk Railroad.
La loro è la stessa storia, ma con un notevole lieto fine economico, di quella
di centinaia di altri gruppi da garage. Insieme già dal 1967, col nome di Terry
Knight and the Pack, per anni cercarono il sound giusto e lo trovarono proprio
nella nuova heavy-music. Folgorati sulla via di Damasco, convertiti a terzetto
dopo che Terry Knight da cantante divenne supremo Produttore-Mentore,
banalizzarono gli arrangiamenti complicati degli Zeppelin, piallarono via gli
orpelli virtuosistici dagli assoli di Hendrix e limitarono le stonature
volumetriche dei Blue Cheer riadattando la distorsione per la massa. Poche idee
e piuttosto confuse, ma grande musica (paradosso?) ed enorme successo. Assieme
a Steppenwolf, Mountain, e nel nome di due grandi Padri-Casuali, gli Iron
Butterfly di In-A-Gadda-Da-Vida e i Vanilla Fudge di Some Velvet Morning, la
missione era compiuta.
La strada, una enorme highway senza curve, che attraversa steppe,
deserti, saloon, motel, bordelli e festival all’aperto, già illuminata al
tramonto da una lunga teoria di luci gialle, è segnata. Allora tutti a bordo,
ragazzi e keep on rockin’!
U.S. Hard-Underground è una raccolta di eroi dimenticati del più
profondo Hard-Rock made in USA (con qualche sconfinamento in Canada…) tra
il 1969 e il 1975. Gruppi disparati, numerosissimi, sconosciuti gli uni agli
altri, sconosciuti soprattutto al grande pubblico, separati tra loro da
migliaia di miglia di Highway, eppure portatori di una idea musicale unitaria e
coerente, asserragliata attorno a poche idee fisse: volume, riff e sesso. Un
vero e proprio Movimento…inconsapevole.
Per capirci, un breve elenco di alcuni dei gruppi e degli album a cui
verrà dedicato spazio:
Mason – Harbour
Maypole – Maypole
Sir Lord Baltimore - Kingdom
Come
Goliath - Hot Rock
and Thunder
Titus Oates - Jungle
Lady
Tongue - Keep On
Truckin’
Granicus – Granicus
Etcetera etcetera …
Questa carrellata non vuole essere né un mero elenco di LP, né una
pomposa raccolta di recensioni, bensì una serie di segnalazioni “selezionate”, una guida turistica all’ascolto di
dischi da scoprire una volta per tutte.
La qualità dell’opera, attenzione, non è MAI un fattore discriminante in questo caso: molte di queste band
sono grette, banali, pedissequamente ricalcate sui successi dei Maestri, così
zeppe di cliché da andare ben oltre il kitsch. Non sono differenti da tanti
titoli deteriori di generi iper-caratterizzati: stanno ai capolavori come Campa carogna... la taglia cresce sta a Per un Pugno di Dollari, ma proprio per
questo oggi assurgono al massimo grado di stracult della più genuina cafonaggine
Hard Rock dei primi anni ’70, rigorosamente oltre i 100 dB.
E il divertimento è assicurato!
Una nuova British Invasion?
The roads are larger now, it’s a grey afternoon in the stars' back yard.
Now I have to write quickly as the altimeter is beating me. The city looks
dusty — L.A. is supposed to be 60 miles across. Sixty miles of freaks, stars,
pretenders, and dollar worshippers — here we come! Toy palm trees, a baseball
stadium. The dinkies become real cars. We’re low and still no airport. You get
that ‘Will we hit the runway' feeling about now. Some American airports are
frightening. Down, down, down - we’ve landed — our American tour begins!
Oil containers, radar towers, Delta, Shell, Castrol, ‘Fly TWA - L.A'.
Captain welcomes us to the USA.
Ian Hunter –
Diary of a Rock n’ Roll Star
Se la prima, più celebre, British Invasion portò oltreoceano il merseybeat
dei Beatles, il primo brit-pop di Kinks e Manfred Mann, il blues bianco di
Stones e Animals, vi fu un altro, minore, arrembaggio inglese alle classifiche
americane tra la fine degli anni ’60 e i primissimi ‘70. E questa volta il
volume era decisamente più elevato.
Alla fine degli anni sessanta, i musicisti
inglesi avevano raggiunto lo steso livello delle loro controparti americane
nella rappresentazione di quello che il rock’n’roll era diventato. Rispetto
alla netta offensiva della prima fase della invasione inglese in America,
quando una schiera di gruppi inglesi si riversarono ai vertici delle
classifiche dei singoli americani, questa seconda fase non era altrettanto
evidente. Nessun artista inglese, ad eccezione dei Rolling Stones e dei Beatles
che erano ancora popolari, era arrivato in testa alle "chart"
americane dei singoli tra il 1967 e il 1970, e soltanto quattro nuove
formazioni britanniche salirono in vetta a quella degli album nello stesso
periodo: Cream, Jimi Hendrix Experience (inglese per due terzi), Blind Faith e
Led Zeppelin. Man mano che gruppi e solisti arrivavano in America portati dalle
tournée in tutto il paese, iniziarono a rendersi conto delle conseguenze
incredibili per loro nel caso che avessero sfondato sul "mercato
americano", e quindi si riformarono e si migliorarono fino a che non
riuscirono a trovare la formula giusta.
Charlie
Gillet – The sound of the City
Dopo la parentesi policroma di psichedelia e idoli di ambigua gioventù
come Beach Boys e Byrds, l’Inghilterra si inventò un formato corazzato di rock
per grandi spazi e maschili frustrazioni.
Ecco una sintetica cronologia di titoli e posizioni in charts per puntualizzare
meglio gli eventi.
Nel marzo 1969 i Led Zeppelin
mettono il naso nella top ten USA con l’album d’esordio, poi, sette mesi dopo,
saranno già al primo posto con II, il
definitivo Vangelo Hard, trainato dal singolo caterpillar Whole Lotta Love (n°
4 nel luglio ‘69). In realtà non furono i primi (né forse i migliori…) ad
aprire la strada, perché l’originale formato pesante a sbarcare in USA fu il Jeff Beck Group di Truth e Beck-Ola,
entrambi al n°15 delle charts nel giugno ’68 e luglio ’69.
Anche i Ten Years After,
forti del successone delle schitarrate folli di Alvin Lee a Woodstock, segnarono
qualche bel punto tra acclamati concerti al Fillmore - poi riapparsi sul
superbo Live at the Fillmore East - e
il prepotente hard-blues di Cricklewood
Green (n° 14 nell’aprile 1970)
In quella stessa estate del 1970 furono i Free a fare centro con il rombo pre-AOR di All Right Now, un riff che fece scuola e un successone tanto in
patria che in USA (n° 4).
Nel settembre 1970 tocca poi ai Black
Sabbath di Paranoid (n° 12), che
faranno anche meglio l’anno seguente con Master
Of Reality, lp nerissimo e scorbutico che pure salirà fino al n° 8.
I Deep Purple, già noti in
USA per l’hit Hush (singolo al n° 4
nel giugno ’68), dopo profonde riorganizzazioni di line-up, ritornano al
successo nel settembre 1971 con Fireball e
soprattutto con Machine Head (n° 7
nella primavera del ’72)
Perfino un gruppo che si direbbe “minore” come gli Uriah Heep, con la coppia di album
fantasy del 1972, Demons and Wizards
e The Magician’s Birthday, entrano in
classifica, posizionandosi in America quasi meglio che in patria.
Ci fu poi il caso estremo dei Foghat,
nati da una costola dei Savoy Brown, sempre in classifica in USA e mai in
Inghilterra dal 1973 in avanti. Situazione analoga, pur con risultati di
classifica più modesti, era anche quella degli Spooky Tooth, una sorta di versione iper-pompata della Band, che
con Soopky Two ebbe un discreto
successo in USA nel 1969, mentre in patria furono sempre ignorati. E viene il
dubbio che l’operazione “Bad Company”
fosse in effetti finalizzata alla creazione di una macchina musicale schiacciassi
prettamente pensata per il mercato USA.
L’America dei primi ’70 brulicava di cappelloni inglesi in tour
perenne: sovente urlatori di rock-blues bianco formatisi alla scuola di John
Mayall e Cream.
L’America dal suo canto fu sì terreno di conquista, ma fu anche subito
pronta a rendere pan per focaccia ai colleghi britannici con gruppi non meno
rumorosi, non meno esagitati… non meno hard. Ed anzi gli antesignani del
movimento duro vanno ricercati proprio tra le pieghe più intransigenti della
psichedelica arrabbiata e psicotica della west-coast, tra le orde di bikers a
spasso il paese, tra pesi massimi delle grandi conurbazioni dell’Est, nonché
tra i reduci delle battaglie di Detroit.
Jeff Beck – Let
me love you
Truth – 1968
Led Zeppelin - Whole
Lotta Love
II - 1969
Spooky Tooth – Evil
Woman
Spooky Two – 1969
Free – All
Right Now
Fire and Water – 1970
Ten Years After – Working
on the Road
Cricklewood Green –
1970
Black Sabbath – Paranoid
Paranoid – 1970
Deep Purple – Smoke
on the Water
Machine Head – 1972
Uriah Heep – Easy
Livin'
Demons and Wizards –
1972
http://www.youtube.com/watch?v=DKxZY0DIxIk
US Hard Rock Overground
A differenza di quanto era successo appena cinque anni prima, al tempo
della British Invasion, alla fine degli anni 60 il rock americano si fece
trovare pronto alla nuova accelerazione imposta dal Regno Unito. Anzi, forte di
precursori di successo, poteva pure rivendicare la paternità dei suoni pesanti,
e non senza ragioni.
In California, area Los Angeles, operava un gruppo di esuli canadesi,
gli Steppenwolf, che avevano fatto
un centro clamoroso con Born To Be Wild,
brano che a cui pare si debba addirittura la paternità dell’espressione “Heavy
Metal”.
I like smoke and lightnin'
Heavy metal thunder
Racing in the wind
And the feeling that I'm under
Sempre a L.A. risiedevano da tempo gli Iron Butterfly, che smerciavano psichedelica pesante a buon mercato
e riff monocordi e pulsanti: In-A Gadda
Da Vida, n° 30 tra i singoli del 1968, fu il prototipo del “brano monstrum”.
Sulla costa est le star tra il ‘67 e il ‘68 furono i Vanilla Fudge: un indecifrabile
guazzabuglio di pop, acido e musica classica, la cui specialità era produrre
cover ipertrofiche e metalliche di canzonette da classifica. Nel mezzo, o
meglio nel mid-west, Detroit, con la sua scena pazzoide capitanata dagli MC5
protetti del guru John Sinclair, in cui power-chord, assoli ipetrofici e volumi
esasperati erano l’unica risposta musicale possibile ai moti di violenta
contestazione che agitavano il Michigan.
Il rock and roll ha dato il calcio d'inizio
al XXI secolo con 50 anni di anticipo, in tre minuti ha fatto il salto dall'era
meccanica a quella elettronica, a 45 giri al minuto, cristallizzando tutte le
nuove energie generate dall'incontro tra queste due mostruose tecnologie,
comprimendole nella forma più compatta, la più esplicita (e implosiva!), per
poi far esplodere quell'energia attraverso la radio in ogni angolo dell'America
per ritribalizzare i suoi ragazzi e trasformarli in qualcosa di sostanzialmente
diverso da quella razza che li aveva messi al mondo.
John Sinclair - Guitar army - Il '68
americano tra gioia, rock e rivoluzione
Su questa solida base si inserì l’hard rock ufficiale “Made in Usa”,
che generò gruppi di fama mondiale, di fama locale e… relitti underground.
Tra i grandi nomi bisognerà ricordare i Mountain, nati dall’incontro del bassista-produttore di Weels of
Fire, Felix Pappalardi, e il mastodontico chitarrista dei Vargrants, Leslie
West. Dopo un album solista dall’indicativo titolo Mountain (1969), il
sodalizio prosegue e il titolo diventa nome della band. Due album fortunati Climbing!
(1970) e Nantucket Sleighride (1971) ed una celebre apparizione a Woodstock.
Cream metallici in formato blindato.
A New York, dove da anni languivano nei vicoli di estati dell’amore
passate ad inseguire chimere, emergono grazie al visionario produttore Sandy Perlman
i Blue Oyster Cult. Additati subito
come risposta USA ai Black Sabbath, coniarono un heavy urbano e paranoico, tra
il b-movie e un innovativo occultismo da pub. Una trilogia di spessore
artistico notevole, Blue Öyster Cult (’72), Tyranny And Mutation (‘73) e Secret
Treaties (’74) poi il successone FM di (Don't
Fear) The Reaper (da Agents Of Fortune, 1976), una liaison con Stephen King
ed una lunghissima carriera. Heavy
Metal con un cervello.
Riding the underground, swimming in sweat
A rumble above and below, hey cop don't you
know?
The heat's on alright
The hot summer day didn't quit for the night
1277 express to heaven, speeding along like
dynamite
1277 express to heaven, rumbles the steel like
a dogfight
You caught me in it's spell
Trying to leave but you know darn well
The heat from below can burn your eyes out
La seconda generazione della rabbia del Michigan fu incarnata dai Grand Funk Railroad, gruppo organizzato
da un dj e produttore tuttofare, Terry Knight che trasformò il suo “The Pack”,
nelle stesse orbite acidule di Amboy Dukes e Frijid Pink, in una macchina da
guerra rock. Fu il gruppo più popolare d’America alla metà degli anni ‘70, con
album come: We're An American Band (1973) o Shinin' On (1974). Mica poco…
E proprio dagli Amboy Dukes fuoriscì uno dei prototipi del guitar hero
post-hendrixiano: Ted Nugent. Enorme
carica fisica, volumi strabordanti, istrionismo spinto. Da qui si arriverà
diretti a Van Halen.
Ma per trovare personaggi forse ancora più interessanti bisogna
scavare, magari indagando tra coloro che
son sospesi a metà tra la Celebrità con lettera maiuscola, che porta donne
e soldoni, e lo sbattimento di costruirsi una reputazione anche solida, ma solo
provinciale, salvo poi, anni dopo, essere additati come misconosciuti
progenitori.
Nel Texas profondo scorrazzavano i Bloodrock, gruppo solido con discografia importante ma scarsa fama.
Un combo di classicissimo sound ’70 con Gibson, Ludwig, Hammond e Marshall e
accordi martellanti soprattutto nell’album d’esordio (Bloodrock, 1970) dove Melvin Laid An Egg fa concorrenza ad Iron Man come riff più stentoreo del
secolo. Spuntarono nelle parti basse della classifica con un brano splatter, D.O.A. (da Bloodrock 2, 1971) che
proponeva una cinematografica soggettiva dal punto di vista del moribondo.
I Captain Beyond, che
incidevano per la Capricorn Records della Allman Brothers Band, parevano dovere
essere una gloria sudista. In realtà erano un supergruppo in piena regola con
un cantante inglese già coi Deep Purple, Rod Evans, un batterista - autore
dalla lunga militanza assieme a Johnny Winter ed una coppia di fuoriusciti
degli iron Butterfly, Lee Dorman e Larry "Rhino" Reinhardt con la sua
spettacolare Stratocaster. Il loro fu un hard dalle tentazioni cosmiche, ben
riuscito soprattutto sul primo LP (omonimo, del 1972).
Nella stessa Detroit degli MC5 prima, dei Grand Funk poi, si erano
stabiliti anche i Funkadelic, una
comune all-black proveniente dalla
costa est che si giocò alla grande la carta dell’acido per un pubblico di Balck
Panther dell’etichetta Westbound. Eddie Hazel, la cui chitarra solista poteva,
nei momenti ispirati, ben rivaleggiare con Hendrix, fu un valore aggiunto al
loro già straripante potenziale. Free Your Mind And Your Ass Will Follow (1970)
era l’estremismo acido e spigoloso, Maggot Brain il successo del primo periodo.
Ma anche col nome di Parliament
facevano scintilla e il riff di Red Hot Mama
(un singolo del 1971) poteva fare impallidire qualunque jimmy Page.
La James Gang di un
giovanissimo Joe Walsh era un tipico power-trio che fagocitava intuizioni di
Cream ed Experience per poi rigurgitare visioni acide e assoloni da outlaw del
vecchio west sostenuti da un batterista che poteva essere Keith Moon nel corpo
di Bob "The Bear" Hite dei Caned Heat. I 12 minuti di Stop (su Yer' Album, 1969) e la macchina
da guerra di The Bomber (su Rides
Again, 1970) valgono il prezzo degli album. La loro è una discografia lunga
(una decina di album negli anni ’70) in cui spicca anche il contributo di Tommy
Bolin.
Se il cantante Sammy Hagar non avesse avuto una proficua carriera
solista culminata con l’approdo nei Van Halen nel 1985, forse in pochi si
ricorderebbero dei Montrose
dell’omonimo chitarrista Ronnie, che si presero sì una fettina di celebrità con
il primo album (e la Bad Motor Scooter di Sammy…), ma
scomparvero presto dal giro importante.
Questa schiera di semilavorati fu la vera cerniera tra i dominatori
delle classifiche e le masse di studenti sbandati che suonavano heavy metal nei
garage di mezza America, ambendo ad una fetta di quella Gloria che sembrava essere
sempre lì a portata di mano, ma che andava coltivata con tanta perseveranza,
tanta tenacia e soprattutto tanta fortuna.
Il treno passa una volta sola e all’epoca furono in tanti a perderlo.
Sono loro gli Eroi che
costituiscono la spina dorsale delle raccolte di US Hard Rock Underground:
glorie locali, sfortunati migranti o semplicemente ventenni con il Sogno nel
cassetto e la chitarra sempre al massimo volume.
Mountain – Mississippi Queen
Climbing! (1970)
Blue Oyster Cult
– The Red & The Black
Tyranny And Mutation
(1973)
Grand Funk Railroad –
In Need
Grand Funk (1969)
Ted Nugent -
Stranglehold
Ted Nugent (1975)
Bloodrock - Timepiece
Bloodrock (1970)
Captain Beyond - Raging River Of Fear
Captain Beyond (1972)
Funkadelic – Friday
Night, August 14th
Free Your Mind And
Your Ass Will Follow (1970)
James Gang – The Bomber
Rides Again (1970)
Montrose - Bad Motor
Scooter
Montrose (1973)
I caratteri di un “genere”
Innanzi tutto, il primo e determinante carattere comune dei gruppi di
US Hard Rock Underground: l'insuccesso.
Le storie di USHRU sono tutte, quali più quali meno, storie di
insuccessi; a volte inevitabili, a volte evidenti, spesso cocenti e dolorosi;
alcuni inspiegabili.
Tutti questi ragazzi avevano un sogno; che si è infranto. Niente
successo, niente celebrità, niente dollari; addio Hollywood!
I really wish to God I could be a Hollywood
Star
Go get'em boy
I'm going to buy you a Diamond
I'm going to buy you a big house
Honey, their ain't nothing money can't buy
I can't believe nobody's loved you
I can't believe nobody's tried
I can't believe we're really living
I can't believe we got to die
Granicus – Hollywood Star
Questo spesso significa anche nessuna memoria: così nomi come Rod
Prince, Peter Alongi o Gary Justin si sono dispersi nei meandri degli archivi
di minuscole case discografiche, anch'esse perse per la ricordo collettivo del
mainstream musicale.
Qual è la formula dell'insuccesso? Più facile di quella del suo
opposto. La maggior parte dei casi è spiegabile nella terribile accoppiata
"cattivo management-deboli idee artistiche"; ma spesso la mala gestione
di un gruppo è facilmente in grado di sovrascrivere qualunque valore artistico,
come ben dimostrano i casi di Granicus o Third Power.
Così, un tour mal programmato, una promozione disattenta o la mancanza
di fiducia nella band (che pur si è messa sotto contratto...) possono
vanificare anche ottimo materiale. Ma occorre tenere presente le responsabilità
dagli artisti stessi, diventare rockstar non è tutto rose e fiori: occorre
perseveranza, disponibilità nell’avere ingaggi da fame in location
terrificanti; occorre pazienza e testardaggine. Perseverare anche se le
condizioni esterne sono del tutto avverse.
Ridin' down the highway
Goin' to a show
Stop in all the by-ways
Playin' rock 'n' roll
Gettin' robbed
Gettin' stoned
Gettin' beat up
Broken boned
Gettin' had
Gettin' took
I tell you folks
It's harder than it looks
It's a long way to the top
If you wanna rock 'n' roll
AC/DC - It's
A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)
L'insuccesso è la vera discriminante tra gruppi dominanti come Grand
Funk Railroad e Mountain e residuati bellici come Highway Robbery, Mason,
Maypole e tanti altri.
Una seconda caratteristica, comprensibilmente derivata dalla precedente,
è l'estrema brevità della vita di
questi complessi, almeno sul versante discografico. Esistenze effimere,
all'ombra di un unico album, due nei casi più fortunati, spesso auto
pubblicazioni per etichette di quartiere in qualche remota città del Midwest;
distribuzione e reclamizzazione pressoché inesistenti. Nessuna foto, nessun
video, scarsi comunicati stampa: quando va bene si pubblica un singolo, poco
altro. Anzi molti gruppi nemmeno arrivarono al traguardo di un intero LP,
fermandosi dopo un paio di 45 giri: qui sta ancora una buia miniera di gemme
nascoste (The Gnarly Beast, Holocaust, Mammoth…).
Sul versante più strettamente musicale, il volume è il comune denominatore sonoro di questi gruppi. I più
estroversi lo scrivevano anche sulla cover del disco: “This record was made to
be played loud!”. Un volume percepito come una necessità, come una presenza
quasi fisica che sta accanto ai musicisti e ai loro strumenti, un volume, che
sull'esempio definitivo dei primi Blue Cheer, è uno strumento aggiunto e deve essere mantenuto alto anche negli stereo di casa, pena un handicap nella fruizione
di Mississippi Queen o American Woman.
Pur con le dovute e mirabili eccezioni, i gruppi di USHRUN mettono
molta enfasi sulla coppia
cantante-chitarrista, l'asse portante di ogni gruppo rock del periodo come
già insegnarono Jagger e Richards. Come detto non mancano le eccezioni ma il
rapporto voce-chitarra, che è poi il rapporto melodia-riff (cioè la struttura-tipo
di moltissime canzoni hard), deve essere determinante.
I love the sound of a guitar playin'...
Yeah
I love the way it makes me feel inside
L'hard rock, salvo rarissimi casi, non è musica per intellettuali. Il che, diciamolo una volta per
tutti, non significa che sia cattiva musica nè necessariamente cattiva
"letteratura”. L'anti-intelletualismo, giocato bene, è un valore di buona
importanza. I testi migliori sono quelli che non si vergognano di un sano
realismo popolare o quelli che non rinunciano ad una buona dose di autoparodia.
I temi trattati spesso sono facilmente riconducibili a tre grandi
categorie che segnano un passaggio importante dalle utopie dei 60 al realismo
di 70 e 80: sesso (piuttosto che
amore); alcool (piuttosto che droga)
e motori (piuttosto che viaggio,
tema caro a tutta la beat generation). Certo è una generalizzazione, ma è utile
a cogliere al volo ciò di cui stiamo parlando.
Sulla strada non è più
importante come scenario della mente, sulla
strada è importante esserci.... con la macchina sportiva giusta e la bionda
di turno sul sedile davanti!
Nobody gonna take my car
I'm gonna race it to the ground
Nobody gonna beat my car
It's gonna break the speed of sound
Oooh it's a killing machine
It's got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
I love it and I need it
I bleed it yeah it's a wild hurricane
Alright hold tight
I'm a highway star
Deep Purple – Highway Star
Sostituendo quasi sistematicamente il sesso all'amore, le tipologie
tipiche di canzone in questo ambito diventano quella di "sesso
goduto", o comunque esibito come trofeo e di "sesso
frustrato"...che è assai comune e spesso si risolve come una
tirata rabbiosa e a tratti misogina che sostituisce le eleganti allegorie di
tradizione blues con immagini ben più dirette.
L'impatto - perché no?- culturale che un pezzo come Starway to Heaven
ebbe sul pubblico americano è difficilmente quantificabile: arpeggi acustici,
visioni magiche e suggestive, nessun riferimento sociale e tantomeno politico,
assolone elettrico, virtuosistico, epico e finale ruggente: tutti elementi
troppo succosi per non tentare i gruppi del college ad una propria personale
versione di questo nuovo standard di canzone soft-hard: la ballata hard rock.
Se gli esempi meglio riusciti sono anche pezzi divenuti oggi mitici
(Free Bird, Astronomy, Hotel California), questo particolare tipo di brano è
diffusissimo anche tra i gruppi minori che non rinunciano alla grandeur zeppeliniana pur non
possedendo, nella maggior parte, altrettanto perizia tecnica e produttiva.
Call me Desdinova
Eternal light
These gravely digs of mine
Will surely prove a sight
And don't forget my dog
Fixed and consequent
Blue Oyster
Cult - Astronomy
Questa mala abitudine può essere considerata come un effetto di un
tratto più generico e diffusissimo in tanti gruppi dell’underground: la mancanza di senso della misura. Mancanza
di equilibrio, di autocontrollo e autovalutazione Si spiega anche così la
tendenza ad inserire nel disco, ad ogni costo, una traccia epica, enorme,
mastodontica, legata da qualche lontana discendenza di sangue con In-a-Gadda-da-Vida;
in parte risposta ai musicisti progressivi britannici, in parte lontano
retaggio di una certa eredità acida.
Macho Songs
You put a greased naked woman on all fours with
a dog collar around her neck, and a leash, and a man's arm extended out up to
here, holding onto the leash, and pushing a black glove in her face to sniff
it. You don't find that offensive? You don't find that sexist?
This is Spinal Tap
Avete messo in copertina una
donna nuda, unta, a quattro zampe, con un collare da cane attorno al collo e il
braccio di un uomo che tiene il guinzaglio e le sbatte in faccia un guanto
perché lo annusi. Non lo trovate offensivo? Non lo trovate sessista?
This is Spinal Tap
Nessuno se ne abbia a male, ma l’hard rock dei primi anni ’70 fu una
musica sessista.
Sessista nel senso che ha sostenuto (e in parte ancora sostiene) evidenti e pregiudiziali differenze tra i sessi.
Esistono le eccezioni, certo, ma sono assai limitate. Il fatto che la maggior
parte dei musicisti e la maggior parte dei fans fosse di sesso maschile è una
causa evidente dell’assunzione di un punto di vista così esclusivamente e
prepotentemente “mascolino” da sfociare in un atteggiamento a volte scostante,
a volte stereotipato, a volte perfino scopertamente misogino.
Del resto, all’inizio degli anni ‘70, dopo qualche anno passato
all’insegna dell’amore libero e femminismo radicale, il rock era precocemente
ritornato su posizioni di arcaico domino fallico senza per giunta giovarsi
delle “buone maniere” ancora in voga negli anni ’50 quando, per la prima volta,
la musica scoprì relazioni non solo d’amore e virtù tra i due sessi.
Recuperando certe allusioni allegoriche tipiche del blues già dagli
anni ’20, la donna ritorna ad essere, né più né meno, oggetto: ora di dolore, ora di piacere materiale. Poco altro.
Peraltro, la rivoluzione sociale del ’68 aveva almeno sdoganato il
sesso come argomento di discussione nazionalpopolare e anche i cantanti ne
beneficiarono non avendo più necessità delle più o meno raffinate metafore di Robert
Johnson.
I even flash my lights, mama, this horn won't
even blow
Got a short in this connection, hoo well, babe,
it's
way down below
I'm goin' heist your hood, mama, I'm bound to
check
your oil
I'm goin' heist your hood, mama, mmm, I'm bound
to
check your oil
Robert
Johnson – Terraplane Blues
In campo Hard Rock Underground esiste una forma ben standardizzata di “canzone
sessuale” che può essere, a seconda dai casi, di “sesso goduto” (ed
esibito come trofeo) o “sesso frustrato” (e causa di rabbia
e risentimento). Inutile sottolineare come in entrambi i casi sia la ragazza ad
essere fautrice del piacere o causa della frustrazione. Suo dovere è
fare sentire il proprio uomo un vero “maschio”, pur se facendolo spesso è
trattata da sgualdrina; ma del resto quando ciò non accade le è immancabilmente
addebitata ogni colpa della mancata relazione (o eiaculazione, fuor di
metafora). Comunque vada, finirà che la troietta avrà comunque spillato quanti
più soldi possibili all’uomo che solo con il sudore della fronte se li era onestamente
guadagnati.
Se certi luoghi comuni derivano ancora dalla tradizione blues, la
sfacciataggine e la boria sono tutte “bianche”.
Nine below zero on the outside,
but I brought my baby's temperature to a
hundred and ten
Nine below zero out on the outside,
and I brought my baby's temperature to a
hundred and ten
Ever since the little girl put me down for
another man
I give 'r all of my money, my lovin' and
everything
All of my money, all my lovin' and everything
I brought my baby's temperature up to a hundred
and ten,
and she done put me down for another man
Sonny Boy
Williamson II – Temperature 110
Da notare poi come la seduzione messa in atto dalla donna sia sempre “inflitta”
quasi con premeditata malvagità e quindi subita
dall’uomo, che, lottando contro la natura, si sforza di non cedere (o
eccedere): un concetto che, estremizzato, conduce alla nota giustificazione
“Non sono io che l’ho stuprata, è lei che stava in bikini…”.
Eva mangiò la mela, Adamo fu spettatore innocente.
Ecco un terzetto di canzoni (che in realtà… sono quattro)
paradigmatiche e che certo hanno ispirato numerosi gruppi dell’ underground:
Evil Woman
Ce ne sono due: un pezzo della band biker-rock Crow, riproposta dai
Black Sabbath dell’album d’esordio e la Evil Woman portata al successo dagli Spooky
Tooth di Spooky Two (1969); quest’ultima vanta un incedere veramente possente
ed un assolone rabbioso di chitarra.
Now I know just what you're looking for
You want me to claim that child you bore
Well you know that it must he not be
And you know the way it got to be
Evil woman, don't you play your games with me
Evil woman, don't you play your games with
***
Woman, thought you were a blessin'
Then I caught you messin'
Evil woman
Woman, you ain't got no feelin'
You're just a dirty dealin'
Yeah
Heartbreaker
Gli stessi Zeppelin che sostenevano che l’anima della donna fosse
stata “creata giù in basso” sfogano
tutta la loro rabbia nel riff più strutturato del secondo album.
Work so hard I couldn't unwind, get some money
saved;
Abuse my love a thousand times, however hard I
tried.
Heartbreaker, your time has come, can't take
your evil way;
Go away, Heartbreaker.
American Woman
Immaginatevi un gruppo francese che porta al successo una canzone
sulle sgualdrinelle italiane. Questo fecero i canadesi Guess Who, e gli
americani apprezzarono molto!
American woman Stay away from me
American Woman Mama let me be
Don’t come Hanging around my door
I don’t want to see your face No more
I got more important Things to do
Then spend my time Growing old with you
American Woman Get away from me
American woman Mama let me be
Don’t come Knocking around my door
I don’t want to see your shadow No more
Colored Lights Can hypnotize
Go and sparkle Someone else’s eyes
Now woman I said get away
American Woman Listen what I say
Ho visto i Guess Who fare questa versione di American Woman dal vivo un anno fa e raramente sono rimasto
tanto offeso da un concerto. Burton Cummings, proprio come fa sul disco, si è abbandonato
ad un’elucubrazione lunga e stizzita
sulla yin yankee in una specie di stile poetico beat esaltato:
American bitch
American cunt
American slut
American lesbian
American school girl
American housewife
American beaver
Ecc, ecc, ecc. Non vi
offendereste anche voi se quel canadese pervertito venisse giù a prenderci
tutti i soldi e anche a denigrare le nostre donne? Certo che sì! Almeno finché
non capite, come alla fine e successo a me, che quel tipo di cose sono proprio
ciò che rende fantastici i Guess Who. Non hanno il minimo buon gusto, non gli
importa nemmeno se mettono in imbarazzo tutte il pubblico, sono dei veri
delinquenti senza neanche dovercisi sforzare.
Lester Bangs - Guida ragionevole al frastuono più atroce
Tra i rocker sconosciuti questo tipo di canzone assume tratti ben
definiti: lunghezza contenuta, vocalità cattiva e soprattutto riff stentoreo,
solitamente il più robusto dell’album.
Power Ballad
Fu una forma canzone assai abusata dai grandi nomi dell’hard & heavy
americano almeno fino all’avvento del punk, ed ancora oggi è una tipologia,
seppur sfuggente e non sempre univocamente definita, assai comune tra i gruppi “pesanti”.
Alcuni caratteri ricorrenti: lunghezza spesso sopra la media, tempo
lento, inizio acustico o comunque assai dolce, assolo imponente di chitarra
solista, crescendo finale, testo malinconico
/ strappalacrime / filosofico.
Di chi fu il peccato originale che diede il via a questo nuovo
standard? Le risposte plausibili sono numerose e vanno da Georgia on My Mind a The
House of the Rising Sun (versione Animals), alla mitica Hey Joe, alla Wild Horses degli Stones, ai Free di tutto quanto Fire and Water, fino a Joe Cocker o addirittura Tom Jones.
Certo che all’atto pratico pezzi come Stairway to Heaven e Child in
Time il loro contributo lo diedero eccome…
Senza i Led Zeppelin in giro, i
loro adepti finirono per ascoltare altri gruppi. Nella breccia penetrarono gli
imitatori degli Zeppelin, per lo più complessi americani che suonavano
fotocopie dei potenti accordi di Jimmy Page, con cantanti biondi che gemevano
sovreccitate sciocchezze mistiche. Tali zeppreplicanti avevano percepito
l'ombra dello Zeppelin quando era passata sopra l'America, all'inizio degli
anni 70. I Boston inaugurarono la serie
delle innumerevoli Little Stairways con il loro inno, More Than A Feeling,
che quell'anno fu un grosso successo negli Stati Uniti. Gli Heart, capitanati
da due sorelle provenienti dallo stato di Washington, suonavano grezze
imitazioni del materiale degli Zeppelin e aprivano addirittura i concerti con
Rock And Roll. Free Bird dei Lynyrd Skynyrd contese a Stairway il ruolo di inno
nelle stazioni radiofoniche americane. Un altro complesso del Massachusetts,
gli Aerosmith, rilesse addirittura Train Kept-A-Rollin’, ricavandone un altro
hit. l Led Zeppelin erano ufficialmente in ritiro ma la loro musica continuava
a vivere tramite quella di altri musicisti (successivamente i fans scherzarono
sul fatto che, in assoluto, i due migliori 45 giri dei Led Zeppelin fossero
Barracuda degli Heart — che prese il giro di basso e batteria da Achilles Last
Stand - e Lonely Is The Night di Billy Squier).
Stephen Davis – Il Martello degli Dei
Pressoché tutti i più famosi complessi dell’hard americano e
britannico potevano mettere in scaletta un brano del genere; nei concerti era
spesso il momento clou, quello in
cui si metteva mano agli accendini e si stringeva la persona amata (o più comunemente
il boccale di birra). Gli esempi sono innumerevoli e a volte assai noti.
Mountain
Un romanticone come Pappalardi può vantare una buona batteria di
ballatissime: dietro la celebre Nantucket
Sleighride (1971) stanno anche Tired Angels e For Yasgur's Farm.
Steppenwolf
Desperation (dal primo
album, 1968) è una potente visione distorta e strappalacrime di quasi 6 minuti
ma John Kay farà meglio ancora con It's
Never Too Late (At Your Birthday Party, 1969).
Rush
Da zeppeliniani di ferro, si gettano in una In the End con esplosione elettrica finale da manuale (da Fly By
Night, 1975 ma anche meglio dal vivo su Exit, stage left). Il tutto
tralasciando Lakeside Park e Closer to the heart, mica poco…
Bloodrock
Robusti mercenari sudisti non facili ai sentimentalismi ma pure assai appassionati
e melensi in Sable And Pearl (da Bloodrock
2, 1970).
Grand Funk Railroad
Nei 9 minuti della complessa suite I'm
Your Captain (da Closer To Home, 1970) spuntano addirittura tastiere
flautate: Detroit li bandì per sempre.
I can feel the hand, of a stranger,
And it's tightening, around my throat.
Heaven help me, Heaven help me,
Take this stranger from my boat.
Grand Funk
Railroad - I'm Your Captain
Blue Oyster Cult
Se Astronomy è uno dei loro
cavalli di battaglia, la stessa Flaming
Telepaths, che la precede nella scaletta di Secret Treaties (1974), non
scherza. Per tacere di (Don't Fear) The Reaper…
Captain Beyond
La super ballata astrofisica è Starglow
Energy (da Sufficiently Breathless, 1973); almeno una variazione sul tema…
Lynyrd Skynyrd
Nell’album d’esordio
addirittura un tris che ha fatto epoca: Tuesday's
Gone, Simple Man e Free Bird.
Train roll on, on down the line,
Won't you please take me far, far away.
Now I feel the wind blow, outside my door,
I'm leavin' my woman at home, oh yeah.
Tuesday's gone with the wind,
My baby's gone, gone with the wind.
And I don't know, oh, where I'm goin'.
I just want to be left alone.
When this train ends, I'll try again.
I'm leavin' my woman at home.
My baby's gone
Tuesday's gone with the wind.
Lynyrd Skynyrd - Tuesday's Gone
Aerosmith
Direttamente dal 1973 di questo ibrido “Rolling Zeppelin”, ecco la
mitica Dream On.
Dopo un brevissimo periodo di interregno punk, la power ballad tornerà
prepotentemente in voga negli anni ’80 fino a trovare il suo vero coronamento
con l’hair metal dei primissimi novanta, quello Don't Know What You Got (Till It's Gone) dei Cinderella (1988) e di
November Rain dei Guns (1991).
I gruppi dell’underground non si fecero pregare e molti di loro si
concessero la propria piccola scala per
il paradiso.
Granicus – Granicus (1973)
Prayer
Undici minuti di misticismo spicciolo dopo la terza birra; per fortuna
c’è un grande cantante che si carica tutto sulle spalle…
The Third Power -
Believe (1970)
Won’t beg anymore
Torpori e lentezze al peyote in stile James Gang
Highway Robbery – For
Love or Money (1972)
All I Need (To Have Is
You)
Questi erano veramente trash, ma un pensierino romantic non lo si nega
a nessuno! Risolvono con inaspettata scioltezza alla CSN&Y.
Zipper – Zipper
(1975)
Face of Stone
Arpeggioni tristi e
pantomime glam.
Ursa Major - Ursa
Major (1972)
Liberty And Justice
Un gruppo fatto per questo tipo di pezzi, c’è solo l’imbarazzo della
scelta. Tutto da manuale.
Zerfas – Zerfas (1973)
Hope
Una ballata in riva al mare che si tramuta in silente contemplazione
elettronica. Occhio perché le stampe in CD fondono assieme più canzoni…
Maypole – Maypole (1970)
Stand Alone
Insipida lungaggine chitarristica da fine lato B. Ma… possibile che
preceda Stairway to Heaven?
Poobah – Let Me In
(1971)
Enjoy What You Have
Modesto proposito da fraticelli francescani con un bel fascino
unplugged
Dryewater - Dryewater (1974)
Thunder
Sembra una paginetta del Vangelo per bambini recitata al Gods of
Metal; con gli accendini in mano.
Alcune note di metodo e qualche
riferimento
Sul blog non sarà riportato
alcun link per il download degli album, né collegamenti a video Youtube. Il
bello di questi LP è il mistero che ancora li avvolge; la ricerca, in rete,
alle aste, nei negozi o alle fiere, per trovare copie originali o rare ristampe
in CD sono la vera missione: un link di Mediafire in questo caso rovina
l’atmosfera, no? ...Poi tanto ci sono centinaia di blog che da anni si sono
specializzati in questo settore…non ne serve certo un altro…
Al contrario saranno fornite indicazioni sui prezzi e sulla
reperibilità degli album sia in vinile che in CD.
Nel lungo elenco di U.S. Hard
Rock Underground troverete solo album pubblicati tra il 1969 e il 1975, il
periodo d’oro dell’hard-rock nordamericano; troverete solo album che non sono
mai finiti in classifica, quindi niente Grand Funk, niente B.O.C., niente
Mountain e compagnia bella: su questi artisti si è già scritto tutto lo scrivibile…non
se ne può più. In oltre: solo LP ufficiali; niente demo, nessun bootleg. Nessun
gruppo esplicitamente Southern: il Southern è un’altra cosa, simile, certo,
alla nostra materia, ma un’altra cosa.
La maggior parte delle informazioni sono tratte dei booklet e dalle
note di copertina di vinili e CD ma ci sono alcuni testi assai importanti, primo
fra tutti Fuzz, Acid & Flowers di Vernon Joynson. Questa è la più
completa ed esauriente discografia della musica americana mai compilata: un
lavoro di titanica pazienza che enumera pressoché tutti i gruppi che abbiano
pubblicato almeno un 45 giri tra il 1964 e il 1972. Anche parte delle
informazioni relative alla rarità dei vinili è tratta da qui, secondo la scala
definita dall’autore che riportiamo qui sotto:
SC Scarce £15 - 30
R1 Rare £30
- 60
R2 Very Rare £60 - 120
R3 Extremely Rare £120 - 300
R4 Ultra Rare £300 - 600
R5 Seldom offered for sale but very
sought-after More than £600
Attenzione però che i prezzi sono datati di una quindicina d’anni e occorre
farle la tara…
The Great Rock Discography di Martin C. Strong è sempre
un’importante fonte di informazione per i gruppi più noti. La guida Goldmine - Records & Prices di Peter
Lindblad e Rare Record Price Guide pubblicato da Record Collector Magazine
hanno poi fornito indicazioni importanti sulle etichette discografiche, gli
anni di pubblicazione e il valore degli album.
Sul versante internet, sono troppo numerosi i blog che già da tempo
hanno cercato di riportare alla luce questa musica; due siti sono però assai interessanti
e si distinguono per un ottimo grado di professionalità:
http://www.lysergia.com che
grazie alla sezione Acid Attic (http://www.lysergia.com/AcidArchives/lamaAttic.htm) vanta una notevole collezione di titoli,
tanto che il solerte autore Patrick Lundborg ha già pubblicato una seconda
edizione del libro “Acid Archives”. Poi l’inossidabile Julian Cope che con il
portale http://www.headheritage.co.uk
ha sicuramente stabilito un personale standard per la divulgazione musicale in
rete.
www.popsike.com ha fornito un
validissimo strumento di valutazione del prezzo dei vinili.
Per quanto riguarda la navigazione sul blog, U.S. Hard Rock Underground è sfogliabile tramite il tag USHRUN, seguendo il link US Hard Rock nella colonna “smart
tag” (a destra) o attraverso la pagina U.S. Hard Rock, che non sarà però sempre
aggiornata all’ultima uscita.
US HARD ROCK UNDERGROUND
ALBUM DI DISTRUZIONE DI MASSA
***
***
***
Artista: Dust
Album: Dust
Anno: 1971
Label: Kamasutra KSBS 2041
Kenny Aaronson: bass,
guitar, dobro
Marc Bell: drums, vocals
Richie Wise: guitar,
vocals
A1 Stone Woman 4:02
A2 Chasin' Ladies 3:34
A3 Goin' Easy 4:28
A4 Love Me Hard 5:25
B1 From A Dry Camel 9:49
B2 Often Shadows Felt 5:10
B3 Loose Goose 3:48
Grandissimi tra i minimi, i Dust ebbero per lo meno il merito storico
di offrire la prima batteria importante a Marc Bell, futuro fratellino Ramones.
E mentre voi state a rimuginare sul reale valore di tale merito, ecco
che questo trio vi riversa già addosso tutta la carica del doppio uppercut
chitarristico di Aaronson & Wise, fautori di un rock duro ma lineare, in
piena scia di Highway Robbery o Poobah, senza derive troppo acide ma con ampie
concessioni alla velocità ed alla professionalità, adeguatamente nascosta sotto
zazzere improponibili e giubbotti in pelle nera, che pure dovettero andare a
genio a quelli della Kamasutra che, dopo questo esordio, concessero loro pure
il bis.
E si capisce anche il perché, magari ascoltando roba come Love Me Hard, che il trio esegue con la
foga di chi sta facendo tardi all’appuntamento con la sgualdrina preferita. Cosa
che per altro accade anche in chiusura, con lo scatenato rock n’ roll di Loose Goose, degno dei Ten Years After
più selvatici.
Troppo facile scegliere i 10 minuti di From Dry Camel come manifesto dell’album? Bè, e allora concediamoci
questa banalità, anche considerando tutte quelle vibrazioni profonde e
veramente dark che il brano si porta appresso, sviluppando galoppate rombanti
su di un riff ipnotico e rallentato, tra Iommi e Dazed and Confused. Metteteci poi la decadenza malinconica di Often Shadows Felt e l’orrorifica
copertina che ritrae tre scheletri in polvere ed ossa, ed il culto è presto
servito.
Non meraviglia poi tanto che questi ragazzini si fecero presto un nome
nel giro di Brooklyn.
Album piuttosto maturo, ben prodotto, ben suonato e ben confezionato,
non stupisce che sia un pezzo noto e sempre ricercato. Molte le possibilità di
trovare una stampa americana (su label fucsia) tra i 50 e i 70$; esistono anche
stampe inglesi e tedesche. Akarma e Kama Sutra stessa hanno ristampato l’album
in vinile in anni recenti e la Repertoire in CD. Da non sottovalutare la
recente uscita Kama Sutra nel formato 2 album 1 CD: prezzi sotto i 10$ anche
per un pezzo nuovo.
Ampia scelta pure in digitale: sia su Amazon che su I-Tunes e Google
Play. Li trovate pure su Spotify.
***
Artista: Moloch
Album: Moloch
Anno: 1970
Label: Enterprise/Stax ENS 1002
Lee Baker: lead guitar,
vocals
Philip Durham: drums, vocals
Fred Nicholson: organ
Steve Spear: bass
Gene Wilkins: lead vocals
Helping Hand
Maverick Woman Blues
Outta Hand
Same Old Blues
Going Down
She Looks Like An
Angel
Gone Too Long
Dance Chaney Dance
Mona
People Keep Talking
I Can Think The Same
Of You
Night At The Possum
Essere prodotti e arrangiati da Don Nix, pubblicare per una
sussidiaria della Stax, basterebbe ampiamente per essere espulsi dal novero
degli Sconosciuti… ma certo questi Moloch hanno studiato assiduamente come
passare inosservati nel sottobosco delle tetre cupezze hard blues.
Cupe quanto, e forse ancor più di quell’ ombrosa swamp che fu Tons of
Sobs dei Free. E se là c’era un Guy Hamilton in forma smagliante, il buon-Don
non rinuncia certo a qualche rumoristico (e umoristico) commentario qua e là.
Un impasto timbrico nerissimo, chitarra di super psichedelica infrangibile,
distorta in bad trips tra Paul Kossoff, Mark Farner e qualche epigono dislessico
di Hendrix. Un soffio ectoplasmatico di Hammond là dietro, ed una batteria
rullante come le ossa di qualche rito voodoo.
Tutto bello… anche perché il buon-Don ci mette lo zampino in
praticamente ogni pezzo e il chitarrista Lee Baker ci sa fare alla grandissima
e vanta una buona militanza tra le seconde file dell’area di Memphis (e troverà
anche modo di incrociare Alex Chilton sulla strada).
Ne salta fuori un blues di periferia, non del tutto al riparo dai
classicismi di Chicago, soprattutto su di un lato B intriso della carica rock
dei Fleetwood Mac epoca Jeremy Spencer e sempre esposto a rituali da ultimo
acido. Dance Chaney Dance potrebbe
essere lo Spencer Davies Group in versione da liceali fatti di peyote. Fino poi
a spingersi in fangose paludi da Hound Dog Taylor nella scalcagnata coda di Night At The Possum, un pub rock di
pregevole scarsa fedeltà.
E certo non può mancare la mitica Going
Down, qui pesante, insistente, meglio di Jeff Beck, ma non certo ai livelli
dell’ inarrivabile versione trash dei Pink Fairies.
Mal che vada… sarebbe sempre il miglior album di Don Nix…
Album nero e ottimamente suonato, il vinile Enterprise originale (ENS
1002) si aggira sui 100$ e oltre, ma non troppo. Vanta una ristampa francese su
vinile e diverse edizioni in CD, tra cui quella Pilot aggiunge due bonus e
qualche apprezzabile nota di copertina; usato si trova attorno ai 10$ più
spedizione. Per gli amanti del digitale c’è Spotify, che fa un po’ di
confusione con gruppi omonimi ma ha tutte le 12 canzoni dell’album originale.
***
Artista: Banchee
Album: Thinkin'
Anno: 1971
Label: Polydor (24 4066)
Peter Alongi: Lead Guitar,
Vocals
Jose Miguel Dejesus: Guitar,
Vocals
Victor William
Digilio: Drums
Michael Gregory
Marino: Bass, Vocals
Fernando Luis Roman: Percussion,
Vocals
A1 John Doe 4:30
A2 Willya 3:30
A3 ¾ Song 3:20
A4 Thinkin' 4:05
B1 Searcher's Life
3:11
B2 Iceberg 3:48
B3 Children Of The
Universe 3:12
B4 38 8:58
E allora mangiamoci a colazione questi nostri amici chicani; con
quella mascolinità sfacciata e tatuata manco fossero i Los Mags per le strade
di Farmington. E farebbero paura a chiunque, poi certo se voi siete degli
scafati Vic Mackey del Rock riconoscerete la naturale e tutto sommato innocua
evoluzione dell’album d’esordio.
Due anni sono passati; dall’Atlantic alla Polydor, un nuovo
percussionista. Scrollatisi di dosso ogni orpello caleidoscopico da
psichedelica femminea, si dedicano ad un latin rock fatto e finito, santaneggianti
come dei Blues Image della costa est. Lontanissimi da casa, ma il suono è
sempre pregevole, la carica elettrica prepotente, l’ispirazione… bè quella un
pochino latita. In compenso arriva una super copertina che in Inghilterra
avrebbe spopolato tra i bravi ragazzi del rock progressivo, e qui invece pare
un - bellissimo, certo - pesce fuor d’acqua. Ma va bene così. Godetevi John Doe (e dimenticate il testo…), gli
intrecci cafoneggianti di Alongi & Dejesus, la miagolante ed obbligata
ballatona di Iceberg, il frammento
hard-Byrds di Thinkin'.
E poi, sorpresa sorpresa… nemmeno questa volta manca il mostro, ed è anche
meglio della vecchia Tom's Island! 38, cioè nove minuti di pretenziosità
southern in salsa chili e chitarre alla Quicksilver (cioè alla Cipollina…) che
certo non fanno prigionieri.
Più macho, ma non troppo migliore del primo, sempre non del tutto a
fuoco come songwriting, Thinkin’ è generalmente un po’ più costoso del lp
d’esordio, con prezzi compresi tra i 100 e i 200 $; il volume di scambi è
piuttosto elevato. Esistono anche stampe tedesche originali. In formato CD è
spesso accoppiato al primo album, a prezzi altini in effetti… Ma in mancanza di
opportunità digitali resta pur sempre la soluzione migliore.
***
Artista: Negative Space
Titolo: Hard, Heavy, Mean And Evil
Anno: 1969
Label: Castle (NS1001)
Rob Russen:
guitar, vocal
Jimmy Moy:
guitar, vocal
Bob Rittner:
bass, vocal
Lou Nunziatta:
drums
The Calm After The
Storm
You 're All I Need
The Living Dead
Forbidden Fruit
Isolated Ivory Tower
Summertime
Hey Wall
The Long Hair
Il fascino ambiguo e a tratti irritante di un bootleg registrato nel
seminterrato umido di qualche pub della East-Coast; la stonatura, la
saturazione, l’improvvisazione totalmente disarmonica, anche qualche chitarra
scordata. Una certa cattiveria lessicale ed un titolo fantastico. I Negative
Space hanno in effetti pochissime frecce al loro arco, ma la distorsione, la
totale mancanza tanto d’armonia quanto di uno straccio di tempo condiviso li colloca
(casualmente) quasi ai limiti del “noise-post-tutto”
più rigoroso, anticonformista, grezzo, alcolizzato e cocainomane.
Un caotico agglomerato di dilettanti a metà tra Sir lord Baltimore,
Morgen e agonizzanti aborti di assoli sanguinolenti nell’idea di un Santana
spastico e autistico in Isolated Ivory
Tower e Hey Wall, mentre la
storpiatura per psichedelia snaturata di Summertime
(proprio quella!) si colloca direttamente in una pregevole estetica del brutto,
alla sezione physica curiosa:
Gershwin dilaniato nel backstage del più scalcagnato palco del New Jersey.
Il gruppo però sfugge al fascino degli opposti quando allenta la
pressione sugli amplificatori e si addormenta su pezzi lenti dalla melassa
sconfortante; in The Long Hair fa
capolino addirittura un abominevole flauto dolce, mentre il buon tentativo di
power-ballad sul riff di Purple Haze
in The Living Dead è zavorrato da un
canto allucinante.
The Calm After The Storm almeno
è violenta, ignorante, rumorosissima, perfettamente maschilista e con un verso
che potrebbe riassumere tutto il mondo di US Hard Rock Underground: Head for the horizon baby, follow the moon /
Today’s an endless highway, tonight a long long trail. E c’è pure l’assolo di batteria! Risolleva le
fortune dell’album anche l’isterismo marcio di Forbidden Fruit, un’amputazione stoner-punk devota al chunk-chunk-chunk chitarristico più
bieco e insipiente dai tempi del garage dei Sonics.
Fosse stato il ’77 avrebbero anche avuto qualche minima chance.
Album poverissimo dal punto di vista tecnico e melodico, vanta qualche
bel sound vintage ed un titolo ben migliore dei contenuti, che gli ha garantito
una pur minima fama tra i cultori.
La storia discografica è intricata e comincia con un’ uscita in vinile
in puro stile “do it yourself” del
1969, con due copertine alternative, una interamente bianca e l’altra nera
(pezzo raro, prezzi indicativamente oltre i 200$, ma scambi inesistenti…). A
questa uscita originaria dovrebbe seguire una ristampa in vinile sempre della
Castle nel 1984, questa volta con una bella cover ipnotica e op-art, bianca e
viola; 8 tracce, label nera. Venduta attorno ai 50 euro, che possono variare
assai in base allo stato del vinile.
Esistono anche edizioni in compact disc a cui ha messo ordine nel 2009
un’esagerata uscita Rockadrome (Rockoio V2) - di fatto riedizione di un vecchio
CD Monster a titolo The Living Dead Years - con tanto di 10 bonus comprendenti
inediti e b-side, per la maggior parte cover di hit dell’epoca da Light My Fire a The Pusher, e incisioni degli Snow, la futura band del chitarrista Rob
Russen: west coast non amplificata e affatto male. Completo ma esagerato.
Artista: Black Pearl
Titolo: Black Pearl
Anno: 1969
Label: Atlantic SD-8220
Bruce Benson: guitar
Jerry Causi: drums
Bernie
Fieldings: vocals
Tommy Molcahy: guitar
Jeff Mackay Morris:
guitar
O'Connor: drums
A1 Crazy Chicken 3:00
A2 Thinkin' 'Bout The
Good Times 4:11
A3 White Devil 4:55
A4 Mr. Soul
Satisfaction 3:35
B1 Forget It 3:41
B2 Climbing Up The
Walls 3:51
B3 Bent Over 2:55
B4 Endless Journey 3:49
B5 Reach Up 4:03
Tre chitarristi sullo stesso palco a nord di Jacksonville? Allora si
può fare!
E questi Black Pearl lo fanno alla grande, progettando di tradurre per
il bianchissimo pubblico del Fillmore le intemperanze nere di Wilson Pickett e Curtis
Mayfield.
Collocandosi nella scena californiana con tutta la freschezza
elettrica dei primissimi Quicksilver e Jefferson che bazzicavano il Matrix,
forti di orgogliose e sbandieratissime basi funky, strizzano tutte quelle 18
corde in riff intrecciati ed efficaci, passaggi alla codeina, tendenze belle
robuste e linee di canto sfrontatamente jamesbrownesche. Apprezzabili per
equilibrio e misura, affatto avvezzi alle esagerazioni, quasi verrebbe voglia
di chiedergli più coraggio e magari qualche banale esagerazione sonora. Ma le
Perle Nere furono, evidentemente, fin troppo rispettose e coerenti; almeno in
studio, perché dal vivo sforavano spesso i dieci minuti a canzone …
Tempi veloci, ritmi multiformi ed impeccabili, passano per quella stretta
cruna che sta fra i Buffalo Springfield e il primo Neil Young solista, con
ampio margine e apprezzabile scioltezza, mentre Tommy Molcahy sbraita invasato
come un’incarnazione mascolina della Joplin, recitando e ripetendo ad libitum la festosa liturgia che
contagiò i fratelli Blues nella cappella di Triple Rock.
Il rock n’ Roll alla Flamin’ Groovies di Thinkin' 'Bout The Good Times o Crazy
Chicken, il potente anthem hard-soul di Forget
It (poi riemerso su Nuggets), anche l’eccitato orgasmo vocale del cantante
invasato in Climbing: ce n’è per
tutti ed accade ad una velocità notevole. Poi, tanto per gradire, ecco in
sottofondo quello strano fascino di alter ego di clonazioni Rollingstoniane accasate
alla Stax.
Non manca nemmeno lo slow blues sessualmente attivo di Reach Up: una grande recita hard boiled
da poliziesco di mezzi ’70. Il tutto da coronamento alle schitarrate di Crazy, southern ante-litteram di scena
all’Avalon Ballroom, e al colorato incubo alla mescalina di Withe Devil: per rinnovare quel clichè
che tanto ci piace del patto tra Rocker e Beelzebub.
Magari non prettamente hard, forse un po’ ripetitivi, ma assolutamente
piacevoli.
Difficile che un’etichetta Atlantic rosso/verde possa diventare un
grande pezzo da collezione e l’esordio Hard-Soul dei Black Pearl non fa
eccezione: con una ventina di euro si trovano belle copie originali.
Quasi più complicato reperire la stampa in CD; ma la presenza
dell’album sul catalogo Spotify risolve ampiamente il problema…
***
Artista: Magic
Album: Enclosed
Anno: 1969
Label: Armadillo ALS 8031
Clyde Hamilton: Organ
Gary Harger: Drums
Duane King: Lead Vocals,
Guitar
Nick King: Bass
Mike Motz: Guitar
Keep On Movin' On 3:25
Indian Sadie 3:59
You Must Believe
She's Gone 4:08
ETS/Zero 2:45
Wake Up Girl 2:37
One Minus Two 2:39
Who Am I To Say? 1:57
I'll Just Play 11:57
Amerika a go-go per un gruppo di arruffati alternativi crogiolati al
sole della Florida, ma pronti poi a trasferirsi nel grigio Michighan per
trovare “Il Sound”.
Enclosed, primo dei due soli album a nome Magic, fu inciso in quel di Miami
e risente di tutto il riverbero solare e salmastro di un southern embrionale,
ancora affascinato da qualche fiore tra i capelli (Indian Sadie). Ben disposti verso sbattimenti hard soul come a
robuste passionalità da Big Brother and the Holding Company, trovano in Duane
King un ottima voce (e un nome mica male…) che fronteggia un gruppo rapace e
convinto, capace di un sound teso ed affilato, soprattutto nei pezzi tirati
come il micro-classico Keep On Movin' On,
Who
Am I To Say? (nemmeno due minuti, ma di puro godimento rock-blues) o ETS/Zero dove certe pigrizie quasi slide
dondolano sornione ed azzeccate. E se pensate che Wake Up Girl sia qualche outtake di Marty Balin o Neil Diamond
aspettate quegli squarci superfuzz
nel mezzo: garage rock in riva alla spiaggia.
Poi, come spesso accade, ultimo viene il colosso. E qui sono i 12
minuti di I'll Just Play che inizia
eterea e atmosferica come fossero i Grateful Dead su qualche tema da Ombre
Rosse scritto da un Allman a caso. Il mantra in sottofondo si fa largo, ma la
chitarra mai lascia spazio, manco fosse Calvary
o The Fool. Anzi l’onda elettrica va
intensificandosi, battente, reiterata, ma non noiosa. fino ad un tramonto
giallo arancio sulle prime colline. Poi effetti, distorsioni, barriti, corde
violentate. Chiudono due eterni minuti sospesi tra effetti Larsen e nastri
backwords. Evviva!
Buon album sospeso tra dura psichedelica e voglia di divertimento, le
stampe originali Armadillo 8031 (etichetta nera e sticker con logo sul fronte)
arrivano a sfiorare i 1000 $, valutazione che pare comunque assai eccessiva
poiché si trovano copie anche per meno della metà (ma pur sempre sui 400 $).
Esistono ristampe in vinile degli anni 90: una non ufficiale della
Hype (HYP 02) e quella della Gear Fab che ha curato anche la stampa in CD.
Quest’ultima aggiunge all’album originale una marea di bonus, singoli incisi
per la Monster e demo del secondo periodo della band, accasata con la Rare
Earth. Materiale vario (Do it e Be At Peace With Yourself hanno un gran
tiro), anche improntato ad un pompatissimo soul bianco con hammondoni sotto e
completo di sezione di fiati. Il CD si trova a prezzi che gravitano sui 10
euro, nulla ancora sul fronte digitale.
***
Artista: Headstone
Album: Still Looking
Anno: 1974
Label: Starr SLP 1056
Barry Flynn
David Flynn
Tom Applegate
Bruce Flynn
A1 Still Looking 7:29
A2 I Like It 7:49
A3 Misery 4:09
B1 Those Days 5:44
B2 Peace Of Mind 5:00
B3 Springtime 4:10
B4 I Love You 5:02
Mormoni del Rock Duro alla ricerca del Senso Profondo. Incompleti, ma ancora alla ricerca come vuole il titolo del loro unico lp. A questi
Headstone, ennesima band rocciosa dell’Ohio, piaceva fare le cose in famiglia,
tanto che in formazione allineano ben tre fratelli Flynn, che si dividono un
ampio suono di organo srotolato a tappetone rosso per meditabondi e pigri brani
di rock alle soglie del cattolico.
Heavy soul, ballate pompate e sermoni ad alta temperatura. Nulla a che
spartire coi suoni acidi della generazione dei fiori, pure se devoti ai Soliti
Nomi e Soliti Numi: Mountain, Vanilla senza farsi mancare i Black Widow più
tediosi. Perché mica sono male, ma alla fine risultano dannatamente pedanti e
piuttosto monocromi nella loro fissità ritmica. Detto questo, il lato A è certo
la parte migliore del lavoro, soprattutto con l’accoppiata delle due prime
tracce: Still Looking e I Like It, in tutto oltre quindici
minuti che partano dalla lunga digressione solista in coda a War Pigs dei Black Sabbath, per
terminare su agili sgroppate di basso che stanno tra l’ovvio sottofondo d
Hammond e qualche bel volo di chitarra. Stessa roba per tutto il resto
dell’album, che pure cerca di elevarsi a versione mistica e ottimista degli
squallori pulp dei Bloodrock.
Tanto che alla fine non sfigurano i quattro pezzi usciti su 45 giri
per la Rome e che alcune edizioni in CD includono in scaletta.
Una azzurra copertina tra il biblico ed il patriottico completa
quest’opera che si giova, in giro, di una certa sopravvalutazione
Album discreto, con un paio di buoni pezzi, Still Looking vanta una
storia discografica discretamente corposa. L’uscita originale è a marca Starr
con etichetta rossa e scritte nere: difficilmente sotto i 200$ ma gli scambi
sono numerosi. Più difficile reperire i due singoli pubblicati dalla Rome.
CD edito nel 2009 dalla Erebus (ERCD038) e nuova stampa in vinile
sempre nel 2009 per la tedesca World In Sound (WIS-011). Prezzi discreti per il CD, ma esistono anche versioni
digitali su Amazon.com e I-Tunes. Dieci euro per l’album completo.
Artista: Goliath
Titolo: Hot Rock And Thunder
Anno: 1972
Label: Bridges (BG-2704-LP)
Dave Wood: keyboards
Paul Bays: guitar,
vocals
Jim Kitchen: vocal
Bill Peters: bass
Steve Peters: drums
1 We´re Not Afraid
2 Ordinary Guy
3 Tell Me You´re
Satisfied
4 Hot Rock &
Thunder
The Apocalypse
5 Silver Girl
6 Dead Drunk
Screamin´
7 The Apocalypse
Goliath, Hot Rock and Thunder. Goliath, Hot Rock and Thunder. Goliath,
Hot Rock and Thunder.
Recitato così come un mantra potrebbe essere il titolo definitivo
della musica dura Americana dei primi ’70. C’è tutto: il nome mistico, il Tuono,
il Rock, le allitterazioni dure di t
e k. Fantastico, almeno in apparenza.
Volendo c’è anche una copertina non male, biblica, imponente, quasi
fantasy. E l’attacco rabbioso dopo i venti siberiani di We´re Not Afraid fa aumentare ancora l’acquolina: una filiazione
terrestre dei Captain Beyond, fin troppo facile al ritornello, ma variopinta di
tastiere che comprendono pure un Clavinet molto Motown.
Ma forse la forma è anche migliore dei contenuti, che pure non
disattendono le aspettative; perché l’album si mantiene in sella ad un blues progressivo da Edgar
Winter con impennate su orbite di tastierismi spinti e a tratti anestetici, che
non fanno paura agli Styx ma pigliano per la coda una certa grandeur che sarà
dei Kansas (Dead Drunk Screamin´). E
se Jim Kitchen si sforza di trovare un timbro mucho macho, il Gran Piano di Dave
Wood a volte dice altro (Ordinary Guy).
Brani assai dilatati, intro e codazzi strumentali non sempre
necessari, ma pur tra effetti simil-galattici, Tell Me You´re Satisfied spara giù un bel riff tosto, e la complicata
The Apocalypse non si vergogna di
concedersi un gran affresco narrativo tra maree di tastiere crescenti e
silenzio profondo prima dell’onda anomala. Peccato per quel sosia di Dennis de
Young che compare al posto dei quattro cavalieri… Per fortuna Silver Girl si riscatta ampiamente con
parti abrasive e volgari che lasciano - è vero - il posto ad una elegia
pianistica al saccarosio, la quale è però gestita con sottile e sospettosa ambiguità.
Divertente.
Godibile LP di hard-prog, Goliath ha una storia alquanto remota. Il
vinile originale dovrebbe essere una stampa privata a label Bridges con etichetta
azzurra-nera e scritta gialla. Prezzi insolitamente bassi, compresi fra i 30 e
i 70 $; probabilmente il “Grande Collezionismo” ha solo toccato di striscio
questa pubblicazione.
Esiste poi un CD della Radioactive, come al solito scarsissimo di
informazioni, ma con almeno una bella riproduzione della cover nella pagina
interna del booklet.
***
Artista: Lucifer
Titolo: Lucifer
Anno: 1970
Label: Gallo
Joe Bertola - Drums
Vincent "Butch" Biocca - Bass
Joe Gallo - Piano
Joe Mattioli - Lead Vocals
Pete Skelton - Lead Guitar
A1 Sixteen
A2 Different Face
A3 Where Do We Go
From Here
A4 Get Together
A5 My Baby
A6 You Better Find
Someone to Love
B1 I'm Gonna Make It
B2 If This World Were
Mine
B3 Dreaming Isn't
Good for You
B4 Crabby Day
B5 Don't Tell Me How
to Love
Ambiguo quintetto italo-americano che pare uscito dalla sceneggiatura
dei Soprano, a spasso per la costa atlantica tra Rochester e New York, i
Lucifer furono autori di un solo album, omonimo, datato 1970.
Sotto una credibile scorza hardrockettona, sgusciano sentimentalismi latini
da soap (You Better Find Someone to Love),
qualche sottile accento di tastiera da piano-bar (If This World Were Mine), una smaccata rivisitazione dei
conterranei Vanilla Fudge (My Baby) e
addirittura l’improbabile cover di un classico west-coast come Get Together.
Ma nel complesso la macchina hard del gruppo funziona con discreto sciovinismo
e buona ruvidezza. Messa da parte la quasi epica ballatissima da night club di Where Do We Go From Here, con antieroici
assoloni e languida vocalità, Joe Mattioli, cantante col nome da peso welter
suonato, trascina tutti quanti dalle parti di una versione beat dei primissimi
Grand Funk appallottolati a grezzi imitatori degli Zombies emersi da
un’autorimessa arrugginita, che vagano raminghi tra i marciapiedi di una
metropolitana di provincia. Basso prominente, wha-wha assortiti, scarsissime
pretese cerebrali e nessuna posa artatamente satanica, come il nome potrebbe
far supporre.
Si finisce addirittura in crescendo, con il prolisso ma robusto funky-pop
di Dreaming Isn't Good for You, in
scia a Bob Seeger, ma soprattutto con la sintetica e a modo suo “modernissima” Crabby Day, che sembra farina del sacco
di Jack White. Don't Tell Me How to Love
torna sulle distorsioni negroidi del primo pezzo, Sixteen: peccato che non tutto l’album sia al livello di questi due
brani.
Scarsissimi gli scambi via web di questo album, in verità non
eccezionale: gli unici documentati superano i 300 $ per il vinile originale (label
Gallo), ma di fatto non c’è mercato… Esiste anche una ristampa in Lp della Void
(Void 25).
L’Akarma ha pubblicatoo l’album in CD (AK 044) in formato digipack.
Prezzi assai competitivi su Amazon.com che ha qualche pezzo usato a partire da
circa 3 dollari.
Disponibile anche in formato digitale su I-Tunes e Amazon. Non
spendeteci troppo, mi raccomando.
***
Artista: Magi
Titolo: Win Or Lose
Anno: 1972
Label: Uncle Dirty's (6102 N13)
John Gaut - vocals
Tom Stevens - bass, vocals
Larry Stutzman - guitar, vocals
Steve Van Laningham -
guitar
Jerry Wiggins - drums
1 Win Or Lose 5:02
2 Undecided Man 3:10
3 I Didn't Ask You 5:46
4 Steve's Jam 4:44
5 Fryin' Away Time 6:53
6 Snow Bound 4:53
7 Runnin' Low 5:39
8 Everytime I'm With
You 4:38
E questi chi sono? Una specie di Grateful Railroad Service? Una
degenerazione heavy-psych della carta smeriglia a marca Pretty Things? Senza
l’ispirazione dei grandi, ma con una carica elettrica e nervosa da fare invidia
e purtroppo mortificata solo da una sottoproduzione che grida vendetta, con quel
sound sputato fuori come da un live a presa diretta, tanto che sembra di
ascoltare la Bibbia del Rovescio della Medaglia. Ma del resto non si può
sbagliare: con quella foto di copertina tra baffi e boccoli, il logo ipnotico e
palesemente op-art, il nome in vago stile art nouveau...
I (Re) Magi in origine erano tre, qui sono cinque, allineano due
chitarre ed un cantante espansivo e generoso, col bel timbro dello
sciupafemmine bastardo e senza pudore.
Esplorano tutte le possibili varianti dell'assolo intricato, del
duello solista e della jam estemporanea, del solipsismo di Gibson alla Alvin
Lee, che spunta fuori a metà di canzoni tortuose come labirinti in bianco e
nero dove fuzz e distorsioni assortite dominano con la strafottenza di maschi
alfa in astinenza di estrogeni nell'aria.
Un album robusto, teso, sempre sulla corda, sempre cattivo al punto
giusto, che concede anche qualche effetto galattico (Fryin' Away Time) ma sta ben ancorato sull'asfalto come una Camaro
sulla 66: basti la galoppata di Everytime
I'm With You, o il basso profondo dello strumentale Steve's Jam.
Manca del tutto il singolo in grado di spaccare-culi-a-destra-e-sinistra, manca la canzone che ti resta in
testa, ma tutto il disco è costruito su un'integerrima, e pur monocroma,
continuità sonora, da ascoltare dal principio alla fine, meglio se sotto l’effetto
di un tasso alcolemico da galera. E poi d'altra parte manca anche (quasi) ogni
concessione al pop, al ritornello, ogni strizzatina d’occhio a radio e college,
perfino nei momenti più zuccherosi di Snow
Bound.
Godevole.
Il vinile originale, una private press a nome Uncle Dirty's (label
bianca), si colloca stabilmente nei territori a 3 cifre, con picchi (esagerati)
di oltre 500 $. Con meno di 300 $ non è facile trovare una buona copia.
Dovrebbe esistere una ristampa Breeder (label arancione) che abbassa i prezzi
fino ad una cinquantina di dollari. Il CD, come tanti di casa Radioactive, non
è molto economico (attorno ai 15 euro usato).
Download digitale disponibile su Amazon (7 euro sulla piattaforma
italiana), ma brani disponibili pure su Spotify, dove si possono ascoltare
anche alcuni B-Side che non compaiono
nella versione in CD: canzoni presumibilmente incise dopo l’album ufficiale,
meno acidi ma potentissimi, come una versione grunge di Montrose più BOC;
notevoli, e questa volta ben prodotti.
***
Artista: Hillow Hammet
Titolo: Hammer
Anno: 1969
Label: House Of Fox (HOF LP 2)
Ronnie Barcley - guitar
Chuck Bennett - vocals,
bass, keyboards
G.C. Coleman - drums
Mike Previty - percussion
Jack Register - bass
Steve Spencer - organ,
piano, electric piano
Pete Williams - guitar
1 Slip Away 5:34
2 Trouble 5:45
3 Fever 3:46
4 Home 4:11
5 Brown Eyed Woman 4:32
6 Nobody But You 2:39
7 Come With Me 3:36
8 We Want To Be Free 5:24
9 Oh Happy Day 7:06
Quella copertina che potrebbe essere stata disegnata da un Peter Hammil
in estasi da Edda Minore, raffigurante una valle florida su cui troneggia un
martello argentato, non potrebbe sviare maggiormente. E passi che il titolo
dell’album sia appunto “Hammer”. Dalle parti di Memphis non è il tempo delle
fate; non lo è mai stato.
Allora prendetevi il vostro pick-up, la lattina di Bud, pulite appena il parabrezza dalla polvere
della strada, e alzate il volume, perchè caterve del più diseducato rock degli
USA profondi vi sta per ricoprire di vapori alcolici e saturnini assoli rotti solo
da sermoni tradotti da un esaltato gospel da pub.
Con un vocione da Bob Seeger isterico in trasferta (Nobody But You) e chitarre onnipresenti
che menano fendenti a caso nel mucchio senza badare troppo all’estetica (Slip Away), gli Hillow Hammet si mantengo
sul sottile filo di una deriva anarcoide apprezzabile, dando fondo a prepotenze
ritmiche e singulti funky di Hammond che disegnano un blues rock intriso di
whiskey e polvere pirica. Home
manderebbe in visibilio qualunque discepolo Southern, mentre Brown Eyed Woman scatena segugi hendrixiani
sulle tracce dei Funkadelic meno in acido.
Sbruffoni come certe sparate dei Cactus o dei Leaf Hound (Come with Me, un riffissimo di splendida
cafonaggine, ma anche la cowbell di We
Want To Be Free mica scherza…), incoscienti come circensi senza una solida
rete sotto, si fanno apprezzare per la velocità dei tempi e la strapotenza di
uno schieramento sonoro che allinea due chitarre, due tastiere e due batterie:
lasciano poco al silenzio e all’immaginazione, ma il loro bombardamento è
veramente a tappeto.
Tanto che le bizzarrie ultra pompate di una cover dark di Fever e una addirittura di Oh Happy Day (sì, quella delle
pubblicità del panettone a Natale…) sembrano quasi al loro posto naturale, in
questo regno di anabolizzati rockettari con capelli che arrivano alle ginocchia
e le Harley rombanti sotto il culo.
Un buon album per i fan del genere; una cover originale seppur
maldestramente illustrata, una label quantomeno remota: scambi ridotto all’osso
ma a prezzi non da vero capogiro. Oltre i 100 euro, sì, ma non più di 200.
Al CD ha provveduto la sempre lodevole Gear Fab: 15 euro circa, tutto
compreso. Su Amazon è disponibile anche il download digitale.
***
Artista: Sir Lord Baltimore
Titolo: Sir Lord Baltimore
Anno: 1971
Label: Mercury (SRM 1-613)
Louis Dambra - Guitar
John Garner - Vocals,
Drums
Gary Justin - Bass
Joey Dambra - Guitar
A1 Man From Manhattan
11:26
A2 Where Are We Going
3:20
B1 Chicago Lives 3:45
B2 Loe And Behold 3:45
B3 Woman Tamer 5:10
B4 Caesar LXXI 5:17
Curioso caso di nepotismo rockettaro, dopo l’exploit di nicchia di Kingdom
Come, i Sir Lord Baltimore imbarcarono in gruppo il fratellino di Louis Dambra,
anch’egli chitarrista, rompendo l’equilatera simmetria del power trio per
aumentare la carica metallica nella speranza di irrobustire il muro sonoro del
loro Heavy Metal psicotico. Ne fece le spese il bassista Gary Justin, relegato
ad un ruolo da comprimario, mentre, da parte sua, Louis si sentì autorizzato a concedersi
prolissi assoli da guitar hero quale assolutamente non era, abbandonando la
sintetica visione demente di Hell Hound
o Pumped Up. Un sound sempre
pregevole pur se più contaminato con pastosità AOR, ma se ci si mette anche John
Garner a diminuire il tasso schizoide della voce, ecco che i fan più incalliti
dello stoner archeozoico storceranno il naso.
In realtà la carriera dei Sir Lord Baltimore finì presto, da qualche
parte negli sterminati undici minuti di Man
From Manhattan, un tentativo di opus magnum che frana sulle sue stesse
fondamenta, alternando velleità angeliche, acquerelli progressivi flautati,
aborti di rock opera e silenzi imbarazzanti, che la portano a terminare su
iterazioni sprofondate direttamente nella Valle della Noia. Un’epica fallita,
maldestra, ambiziosa e senza sostanza che sotterrò del tutto la gloriosa
avventura dell’album d’esordio. Con un’ apertura del genere l’album appare
segnato… soprattutto se a ruota segue una traballante versione psudo-funky di Where Are We Going con tanto di sax e Hammond,
manco si fosse materializzata una cover band liceale di Sly Stone in versione
ariana.
Peccato perché il resto dell’album è ben gestito, pur soffrendo sempre
tremendamente il confronto con l’esordio. Dalla costola blacksabbathiana di Caesar LXXI, con vocalità alla Ozzy in
bell’evidenza, ai riffoni dinosaurini di
Chicago Lives e soprattutto Loe And Behold, fino alla definitiva Woman Tamer: uno stoner anni ’90,
scolpito nella roccia, con chitarroni profondi, basso vibrante e struttura
intricata. Blues for the Red Sun vent’anni prima. Homme e Oliveri ringraziano.
Vinile assai “svalutato” rispetto al primo album del gruppo;
l’impressione è che con 60-70 euro e un po’ di fortuna sia lecito accaparrarsi
una stampa USA (Mercury SRM 1-613). Esistono riedizioni recenti sempre della Mercury
su vinile a 180g. Discreta la cover.
In CD è spesso accoppiato con Kingdom Come a prezzi a volte un po’
elevati. Download digitale disponibile su Amazon ($5,99).
***
Artista: Banchee
Titolo: Banchee
Anno: 1969
Label: Atlantic 8240
Lineup:
Peter Alongi - Lead Guitars,
Vocals
Jose Miguel Dejesus -
Guitar, Vocals
Victor William
Digilio - Drums
Michael Gregory Marino
- Bass, Vocals
Johnny Pacheco – Percussion
Tracklist:
The Night Is Calling 3:30
Train Of Life 3:21
As Mу Thinks 3:11
Follow A Dream 4:28
Beautifully Day 5:10
Evolmia 3:24
I Just Don't Know 3:17
Hands Of A Clock 4:14
Tom's Island 8:49
Un gruppo di latinos sotto copertura; quintetto di newyorchesi con la
West Coast piantata nella testa. Si sforzano di dare risposta alle nevrosi
della costa atlantica sfogandosi in intricati happening chitarristici, ma
riescono solo a sentire più forte la nostalgia per il sole della California. I
Banchee sono l’ombra chicana dei Crazy Horse senza un cantautore a guidarli; e
allora scelgono di giocarsi tutto sul timbro affascinante di melodie appena
zuccherose che hanno a volte la fastidiosa tendenza a sovrastrutturarsi in
produzioni complesse che non rinunciano ad orchestrazioni per archi e ottoni
stile All You Need Is Love (Follow A Dream) o in parti vocali tra il
melenso e l’angelico, che fortunatamente non sovrascrivono nè le belle
distorsioni per chitarre gemelle di Beautifully
Day, né la pregevole elasticità della sezione ritmica, e neppure certi riff
violenti, almeno nelle intenzioni (Evolmia).
Con una buona dose di cinismo urbano in più avrebbero potuto essere i Blue
Oyster Cult, piuttosto che una versione pallida di Santana; in realtà hanno
ripiegato su brani sbilenchi di certa para-psichedelia britannica (Hands Of A Clock) da Pretty Things
ignari delle avventure dei colleghi rotolanti. E bisogna dire che le resa
finale non è assolutamente male, ma certo l’Atlantic del 1969 sapeva come fare
suonare i suoi dipendenti.
In una miriade di spunti interessanti, come il rullante pop-blues
ferroviario di Train Of Life,
rimangono ben in mente la strafottente distorsione di As Mу Thinks con tutti i suoi latineggianti cambi di ritmo, e il
bel distillato proto-hard di I Just Don't
Know che finalmente nulla concede alle armonie celesti e che infila un filotto riff-strofa-assolo di
bel lignaggio.
Alla fine i chitarristi Alongi
& Dejesus tentano anche la carta dell’epica, edificando gli otto
minuti e mezzo di Tom's Island come
fossero l’ibrido Beach Byrds impegnato nella traduzione di qualche rock-opera
Mod. Bel suono, approccio d’imponente fattura, ma non mancano passaggi di
stucchevole autocompiacimento.
Un lavoro a tratti ridondante per un gruppo che lascia l’amaro in
bocca per non saper sfruttare un grande sound e una bella coesione interna.
LP di prog-pop dalla spiccata vena hard, Banchee è annoverato tra i
classici dimenticati del suo tempo, a torto spesso associato ad orizzonti acidi
e fricchettoni che in realtà non gli appartengono del tutto.
L’imponente distribuzione Atlantic non ne ha ancora fatto un pezzo da
collezione, pur essendo un album perfino sopravvalutato dal punto di vista
artistico: il vinile originale USA (classica label rosso/verde e inserto con i
testi) gode di un buon volume di scambi con prezzi che difficilmente superano i
100 $ (cifra in effetti esagerata sia per il disco sia per la label…).
La ristampa in CD della Lizard accoppia i due album del gruppo: comodo
ma costoso (tra i 15 e i 30 euro).
Bella la cover dal vago gusto orientale.
***
Artista: Josefus
Titolo: Josefus
Anno: 1970
Label: Mainstream
6127
Line Up:
Pete Bailey: vocals,
harp
Dave Mitchell: guitar
Doug Tull: drums
Ray Turner: bass
A1 Bald Peach 2:42
A2 B.S. Creek 4:04
A3 America 2:38
A4 I'm Gettin' On 2:30
A5 Sefus Blues 3:12
B1 Jimmy, Jimmy 2:39
B2 Feelin' Good 6:10
B3 Condition 3:01
B4 I Saw A Killin'
2:23
B5 Such Is Life 3:07
Questi quattro elettrocowboys riescono ancora a spandere generose dosi
di stoner paleozoico, e se è vero che riemergono dalla caverna misterica in cui
fu concepito Dead Man, lo fanno solo
per addentrarsi nel sottobosco di una foresta pietrificata nel deserto, a
caccia di vampiri diurni come in un film di Carpenter.
Generalmente questo secondo album è additato come una delusione. E
perché? Manca, certo, il mega-brano-esagerato, il Moloch a cui sacrificare
giovani vergini dalla pelle chiara al primo appuntamento “Ehi, ti piace la
musica?...ti faccio ascoltare un pezzo…”. Però il gruppo riesce a non cambiare
del tutto il proprio sound fatto di buio e catacombe (cosa che per esempio non
riuscì a Sir Lord Baltimore, Captain Beyond, Hard Stuff e tanti altri…). E pur
spalancando finestre di luce diurna assai californiana (Iron Butterfly,
Jefferson, Steppenwolf…), Tull & Turner sono sempre martello e incudine di
una fucina sonora foderata di piombo, in cui il buon Dave Mitchell scopre
finalmente “la sovra-incisione” e riempie quegli spazi vuoti (che certo, erano
fantastici…) con strati di chitarroni hard-western che dopo trent’anni sono una
fantastica reliquia del tempo che fu.
Peccato solo per quella canzoncina soft di Jimmy. Jimmy, melenso tributo a Hendrix, che sgonfia totalmente
questa nuova bolla scura in cui il gruppo aveva tanto faticato a rinchiudersi:
la canzone in sé neanche è orrenda, ma ammoscia terribilmente una bella
tensione accumulata per tutto il lato A. E per fortuna che a ruota c’è subito Feelin’ Good, ridondante hard-rockkone
sessista, stracolmo di chitarre e birra, che avrebbe potuto essere il nuovo
Moloch e invece viene tarpato sul più bello, quando anche il canto debosciato
di Bailey aveva finalmente trovato una sua maschia teatralità.
Il gruppo non ha poi del tutto abbandonato nemmeno le elucubrazioni
sulla morte (Condition, I Saw A Killin') né certe profondità
doom (Bald Peach) e questo disco,
piaccia o no, segna un piccolo passo avanti dal punto di vista meramente
sonoro.
B.S. Creek è forse la loro
canzone migliore, una sfrenata cavalcata chitarristica post-hippy che decolla
in effetti spazialeggianti su una sabbia rossa di Marte percorsa da bikers
indomiti con la Colt carica in cintura. La vendetta di Mick Bolton, con tanto
di riff-che-non-dimentichi e che da
vent’anni Josh Homme svende alle masse di Lollapalooza. E se America si concede a sane ideologie sinistroidi
come un brano di John Kay suonato dagli Iron Butterfly che copiano Volunteers, beccatevi il riffone di I'm Gettin' On, brano che degenera
presto nei power-chord assassini di Mitchell. Sefus Blues è una sceneggiata agonizzante di Pete Bailey alle prese
con un serpente a sonagli che si trascina nella tana al crepuscolo. Condition ritorna nei territori
californiani di America, ma il
cantante sfodera la bella pantomima di un vagabondo serial killer che sta
morendo di sete nel Mojave mentre la chitarra divaga meravigliosamente senza
costrutto. Alla fine resta, con il suo antiquato moraleggiare, solo il country
stonato di Such Is Life.
Peccato che qui finisca anche la storia dei Josefus, riemersi più
volte negli anni a venire, ma minati dalla tragica fine del pittoresco
batterista, ufficialmente impiccatosi in carcere dopo essere stato arrestato
per possesso di stupefacenti. Un’ ennesima morte rock su cui, questa volta, ben
poco si indagò.
Album perdente nel confronto diretto con Dead Man, Josefus segnò il
passaggio della Band di huston all’etichetta Mainstream. Vinili originali
(etichetta blu-nera) sopra i 150$ ma difficilmente oltr i 300$: manca tutta
l’aura mistica dell’esordio.
CD piuttosto costoso (oltre i 20 euro, in media) meglio ripiegare
sull’edizione che accorpa i due album del gruppo. Versione digitale a 7,99 euro
su Amazon.it, 8,99 su I-Tunes.
***
Artista: Euclid
Titolo: Heavy Equipment
Anno: 1970
Label: Flying
Dutchman - Amsterdam (AMS 12005)
Line Up:
Gary Leavitt -
Leader, Guitar & Vocals
Harry
"Maris" Perino - Bass & Vocals
Ralph Mazzota -
Guitar & Vocals
Jay Leavitt - Drums
& Vocals
1 Shadow Of Life, On
The Way , Bye Bye Baby
2 Gimme Some Lovin'
3 First Time Last
Time
4 Lazy Livin'
5 97 Days
6 She's Gone
7 It's All Over Now
Album di pesantissima fattura già dal titolo e dalla cover, che ritrae
i quattro musicisti alla guida di un enorme bulldozer, Heavy Equipment è il
prodotto di una sorta di supergruppo del Nord Est formato da ex-membri di
Cobras e Lazy Smoke, piccole glorie di tarda psichedelia regionale. Due
chitarre, basso, batteria, un fracasso
allucinante e un amore viscerale per la scena Londinese di East End, per questi
fanatici heavy-mod del Maine.
Tanto per non lasciare spazio a dubbi, ecco gli undici-minuti-undici di Shadow
Of Life/On The Way/ Bye Bye Baby una mini-opera hard in tre parti, a metà
tra le suite di After Bathing at Baxter's, certi pezzi metallici e modulari dei
Nazareth e passaggi iper-ritmici à la Pete Townshend. Shadow Of Life dispiega uno spettacolare effetto metallico, è zeppa
di riverberi esagerati, riffoni clamorosi tanto più efficaci quando risuonano
nel registro basso delle chitarre, tanto più monumentali se in contrasto con
coretti di voci bianche di spudorata ambiguità. Bye Bye Baby chiude il trittico con passaggi di rabbia furente
mitigati appena dalla magniloquenza melodica degli interventi solisti, mentre
nella parte centrale i fratelli Levitt sfoggiavano un industriale ralentissement da distorta
sbornia post-acida.
Non c’è tregua perchè la cover di Gimme
Some Lovin' restituisce la hit dello Spencer Davis Group in una versione da
horror adolescenziale di bassa lega, un’esagerazione megalomane del rock
alternativo dei Flamin’ Groovies, prima con un terrificante incedere cingolato,
poi enfatizzando il giro armonico discendente, ricoperto con cascate
hendrixiane che ne fanno un curioso ibrido tra Foxy Lady e I’m a Man dei
Chicago: pezzo definitivo della megalomania testosteronica dell’Hard Rock
yankee; da ascoltare.
Per i feticisti kitsche c’è la bizzarra Lazy Livin' che è un pastiche distorto tardo-fricchettone con tanto
di giardinetto zen di manifesta pacchianeria e sitar deformati e scarnificati
prima di un banale chorus à la David Crosby che aspetta il trapianto in sala
operatoria. Gli onanisti dell’Heavy-Rock troveranno addirittura non una ma tre
polluzioni: First Time Last Time, 97 Days e She's Gone. Pezzi di sintetica cattiveria, che avanzano col passo
della IV Panzerdivision tra ritmiche martellanti ininterrotte ed effetti chitarristici
di notevole modernità, sempre dominati con maturità dall’inscindibile coppia
ritmica dei prodi Levitt & Mazzota. She’s
Gone fa bella mostra del riff più efficace del Nord-Est, sintetico come
piace a Roger Glover, ininterrotto, ciclico e potenzialmente infinito:
l’ingranaggio dentato di uno schiacciasassi assassino. First Time Last Time si diverte nell’interplay ritmico tra le
chitarre e sarebbe ben mimetizzata perfino su Metal for Muthas. Basta così; It's All Over Now è la banale nota
super-mod che chiude questa cavalcata diesel su cingolati da battaglia. Nessun
altra uscita discografica per il gruppo.
Piccola etichetta, grande valore. I vinili originali Flying Dutchman
(etichetta rosso-gialla a cerchi concentrici) non scendono sotto i 150 $ e le copie
migliori ormai si assestano stabilmente oltre i 250.
CD ristampato con parsimonia: tra i 12 e i 20 euro, con prezzi più
convenienti su Amazon.de. Riscoprirlo può valerne la pena.
***
Artista: Salem Mass
Titolo: Witch Burning
Anno: 1971
Label: Salem Mass SLP
101
Lineup:
Jim Klahr - keyboards
Mike Snead - guitar,
vocals
Steve Towery - drums,
vocals
Matt Wilson - bass,
vocals
Tracklist:
Witch Burning 10:26
My Sweet Jane 4:35
Why 2:44
You Can't Run My Life 3:50
You're Just A Dream 3:42
Bare Tree 6:53
The Drifter 3:14
Chi si fosse trovato, nel 1682, a passare per la cittadina di Salem,
Massachusetts, avrebbe potuto udire le grida di ragazze disperate e l’odore di
fumo del più retrogrado oscurantismo cristiano (si, cristiano) che mise al rogo
19 persone accusate di stregoneria e ne torturò e perseguitò altre centinaia
(si, centinaia).
Una pagina così truculenta non poteva certo scampare alle attenzioni
dei rocker sotterranei cresciuti all’ombra di Black Sabbath, Coven e Black
Widow…
Furono i Salem Mass, della lontanissima Caldwell, Idaho, a produrre
Witch Burning nel 1971; album dalla dubbia ispirazione ma pur sempre interessante
quanto sanguinolenta testimonianza di un
certo shock-rock venuto alla ribalta con Alice Cooper e Bloodrock. E in realtà
il lavoro non è poi esageratamente splatter nonostante la tetra copertina.
Certo, la mastodontica jam d’apertura dispiega in oltre 10 minuti
tutta la truce potenza di una sorellina minore di In-a-Gadda-da-Vida: riff circolare, azzeccato, tenuto perfettamente
a galla dal basso per tutta la durata di un brano in cui una chitarra
black-blues di robusto stampo e gli eroismi tastieristici di un Emerson di
provincia si scambiano le parti soliste come in una versione da incubo di Light My Fire. Un pezzo imponente, privo
di misura ma non di un sottile equilibrio che ci risparmia minuti di noia;
datatissimo eppure divenuto un classico dimenticato del west più profondo, cantato
oltretutto con la teatrale schizofrenia di un Grande Inquisitore autoproclamatosi
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il tono di scura
mestizia si fa ancora più profondo con My
Sweet Jane, la canzone più intrigante: una sonata corrucciata per piano
elettrico, falsamente urbana, che disegna nell’aria del tramonto depresse figure
di ombrosa femminilità violata.
Il resto dell’album si muove per vie più consuete tra biker rock come Why, un’intrusione appena psycho-pop in You're Just A Dream e il classico
riffone maschilista di You Can't Run My
Life: un’esplosione metallica tra Iron Butterfly, Steppenwolf e Captain
Beyond con l’aggiunta del timbro progressiveggiante delle tastiere di Jim Klahr
che offre un impasto sonoro veramente godurioso.
Alla fine marca un bel punto Bare
Tree, una lunga divagazione tra frustate assai hard e strofe di autunnale
distensione, aperta da un maestoso organo da Chiesa Alta e in bilico precario
tra Vanilla Fudge, i primi ELP, e degli strani Doors che, in favore di scenari
di britannica sperimentazione, hanno rinnegato i blues di Jimbo.
Tre volte, prima del canto del gallo; e dell’ennesimo rogo.
Album raro, argomento horror, opener mastodontica: c’è tutto per fare
di Witch Burning un oggetto di culto vinilico; e infatti la stampa USA
originale (di fatto un’autoproduzione: Salem Mass SM 101) viaggia costantemente
tra i 100$ e i 300$... nemmeno tanto in realtà, ma gli scambi sono
ridottissimi. In vinile è anche l’edizione Akarma, mentre la Gear Fab ha ristampato
l’album in CD nel 1999: un po’ ovunque tra gli 8 e i 10 euro più spedizione.
***
Artista: Dryewater
Titolo: Southpaw
Anno: 1974
Label: J.T.B. NR 5122
Lineup:
Robert Blair - Bass,
Vocals
Richard Drye - Lead
Vocals, Guitars
Shaye Drye - Keyboards,
Vocals
Garland Walker
Stidham - Drums
Tracklist:
A1 Winterground 3:02
A2 Trouble 4:07
A3 Give Yourself Time
To Live 3:24
A4 Don't Let Her
Sleep Too Long 2:58
A5 Let Me Take You 3:31
B1 Thunder 2:57
B2 See Them Run 2:02
B3 Revelation 2:23
B4 Set Out On Te
River 2:49
B5 After All (I Ain't
Sleepy) 6:30
Un piccolo LP, cresciuto tra i campi al sole della Nord Carolina senza
originalità, magari con non troppa competenza ma a cui non si può volere troppo
male. Prodotto da quattro ragazzi entusiasti, incalliti buonisti che non
avrebbero rinunciato ad un “happy end” nemmeno in cambio di un assolone heavy
blues, di un riff a cappella di Les Paul o di un urlatore drogato in paranoia
da metadone, nonostante una copertina scura e ectoplasmatica, minimalista ma
non foriera di orrori sonori nè tristezze cosmiche.
Quello dei Dreywater è un rock governato dal bel timbro del piano
elettrico sommato ad una chitarra suonata da un reduce della Baia infatuato di
suoni duri ma cresciuto negli ampi spazi collinari degli Appalachi più dolci, quasi avvezzo al country
e al folk (ma non ditelo a nessuno). Ballate estive, accordature aperte,
ritornelli facili, slanci solistici assai controllati, nessuna bizzarria. Non
mancano i momenti di purezza hard come Winterground,
rubata agli Uriah Heep e regalata alla sponda più dura di un certo acid-rock
senza utopie, ma soprattutto i lunghi minuti di schitarrata conclusiva di After All (I Ain't Sleepy), epilogo
southern al tramonto su autostrade percorse da un Dickey Betts analfabeta
accompagnato da Quicksilver, Skynyrd e Blackfoot. Nel mezzo: tanti spunti di
country n’ roll sincopato alla Creedence, frammenti da 45 giri marca Stones (Trouble), perfino una ridondante
liturgia epica grazie a Thunder, un piccolo
inno da cantare in coro alla luce degli accendini.
Ciò che resta maggiormente sono canzoni appena dolciastre come Give Yourself Time To Live, ma
soprattutto la favola hard-country di Don't
Let Her Sleep Too Long, uno di quei pezzi che si ascolta volentieri tre o
quattro volte di fila prima di realizzare quanto sia semplice e ripetitivo… eppure
ben fatto. E peccato che la batteria fatichi a togliersi di dosso una certa
scolastica tendenza all’appiattimento, altrimenti See Them Run o Let Me Take
You ne sarebbero saltati fuori ben meglio, anche se quei gridolini alla Immirant Song fanno veramente rabbrividire.
Eppure, ripetiamo… non vogliate troppo male a questi Dreywater.
Nessuno li ha mai conosciuti né considerati; loro, che cercavano solo un “happy
end” che accontentasse tutti.
Polveroso e privo di genialità, Joyson lo classifica come disco R3 e
la remota etichetta J.T.B. (label nera a scritte bianche) assicura prezzi
elevati: pochissimi gli scambi, tutti compresi tra i 250 e i 450$, troppo per
un album di media qualità e scarso interesse collezionistico.
Esiste una ristampa in vinile (Void - 1997) con due inserti (testi e
foto) in edizione limitata: al massimo una cinquantina di dollari, ma a questo
punto meglio il CD della Radioactive (RRCD 161): tra 8 e 10 euro più
spedizione. L’album esiste anche in formato mp3 su su I-Tunes: 8,99 euro (0,99
per canzone).
***
Artista: The Third Power
Titolo: Believe
Anno: 1970
Label: Vanguard VSD
6554
Line Up:
Drew Abbot: guitar, vocals
Jim Craig: drums, vocals
Jem Targal: bass, vocals
Tracklist:
Gettin' Together 4:18
Feel So Lonely 4:17
Passed By 3:43
Lost In A Daydream 2:31
Persecution 3:24
Comin' Home 3:49
Won't Beg Any More 4:28
Crystalline
Chandelier 3:41
Like Me Love Me 5:23
Ringraziate il benevolo Dio del Rock, il Dio dell’Amplificazione, la
cui mano ha accarezzato le menti di questo terzetto di terroristi fuorusciti
dall’iper-politicizzazione delle strade di Detroit, sottraendosi ai decibel
delle White Panther per dimostrare che questo loro hard rock non ha altra
bandiera se non quella del divertimento. Un Terzo Stato del Metallo che sbraita
nella Sala della Pallacorda, questa volta senza rivoluzioni in vista, ma con la
presunzione di mischiare in un unico LP mille esperienze di un passato allora
recentissimo: Cream, Hendrix, James Gang, fracasso inglese, radici blues.
Come in Gettin' Together,
quando Drew Abbott si inietta direttamente in vena tutta Funky Dollar Bill dei Funkadelic di Free Your Mind, trasfigurati
dalla ridondanza bronzea di Black Sabbath del Midwest, forgiando un riff
memorabile e senza paura di lanciarsi nelle peripezie di assoli senza rete,
retti sul filo di un contenuto delirio ipercinetico e una linea vocale assai
maschia. Mettiamoci la produzione di Sam Charters, per la Vanguard (la Vanguard!
quella di Chicago - The Blues today!) che tanto richiede alle orecchie e al
cervello di chi ascolta, mimetizzando, sotto strati di distorsione, chitarre
che in realtà mantengono tutta la tagliente piattezza di un vecchio blues a 78
giri, e che, nei momenti migliori, replicano l’affascinante atmosfera da
officina musicale delle produzioni di Guy Hamilton per la Island. Otteniamo un
album scatenante, volitivo, basato sul funkeggiamento autostradale di Persecution, brano di superba frustrazione
e risentimento che contiene la bella frase “All
my friends, they don’t like the way i play guitar...” declamata con rabbiosa
ironia mentre Targal jackbruce-eggia tarantolato; su Comin' Home retta da un doppio riff basso-chitarra
in pura opposizione di fase; ma basato anche sulle distorsioni
post-psichedeliche di Feel So Lonely,
che rispolvera i primi Cream pseudointellettuali di I Feel Free e concede al chitarrista una onesta dose di controllata
megalomania.
Ma questo terzetto non si sottrae alla sfida della sperimentazione e
dell’ecletticità voluta, ricercata, strappata a morsi da un’attitudine che, pur
tipicamente heavy, si concede alla ballatona Passed By, acustica quanto basta, finchè non entra uno scalcagnato
pianoforte verticale depresso come i Moot the Hoople di Wildlife; e non disdegnate
neppure il riff alla Beggars Banquet di Lost
In A Daydream, che in realtà sostiene un pop solare di memorie primaverili
in riva al mare danzando con gli hippy attorno al falò, un pezzo che forse sarebbe piaciuto a Marty Balin e sicuramente a
Chris Isaak, mentre avrebbe mandato su tutte le furie MC5 e Grand Funk. Poi la
grandiosa visione sonnolenta e stordita di Won't
Beg Any More, una James Gang enorme, deformata al caleidoscopio di un light
show dell’UFO Club, che si concede a intermezzo latini prima di concludere su
un gran voltaggio di chitarre e figure retoriche di basso a profusione. Il
basso, questa volta in contorsioni progressive, accende anche Crystalline Chandelier, una nuova pigra
digressione meditabonda che finisce tutta dentro Like Me Love Me, riffone poderoso borchiato su pelle nera, nel
tipico caos strumentale ultra-hard di fine Lato B dell’epoca.
Che siate o meno tra gli amici di Drew Abbot, questo è un LP assai
stimolante, un unicum per la Vanguard, un unicum per il gruppo stesso che al
tempo fu definito “for masochists only”
: ne potevano andare fieri!
Vinile originale Vangurad (etichetta beige, inner illustrata) tra i
70$ e i 100$, ma il numero di scambi è piuttosto elevato e si può sempre
trovare il colpo di fortuna. Esistono almeno due ristampe in vinile di cui una
piuttosto recente di casa Akarma.
La Relics ha ristampato il CD nel 2010, con due bonus e ottimo audio:
tra i 10 e 15 euro su Amazon con prezzi più vantaggiosi in UK. 8,99 euro per la
versione mp3 su I-Tunes (1,29 ogni singolo brano).
***
Artista: Poobah
Titolo: Let Me In
Anno: 1972
Label: Rite-Peppermint (PP 1015)
Jim Gustafson: guitar,
vocals, keyboards
Phil Jones: bass, vocals
Glenn Wiseman: drums,
vocals
1 Mr. Destroyer
2 Enjoy What You Have
3 Live To Work
4 Bowleen
5 Rock'n Roll
6 Let Me In
Intendiamoci: Mr. Destroyer
è l’unico pezzo che potrebbe degnamente illustrare i titoli di testa de “La notte degli Hell’s Angels Licantropi”:
Les Paul a valanga su caterve di Marshall, riff spogliati di ogni virtuosismo e
abbellimento, rivestiti solo di volume e alcool, assoli degenerati di wha-wha
sotto tortura e un intermezzo assurdo per grida belluine di chi sta subendo una
scarnificazione senza anestesia.
Let Me In è un album che si porta dietro una grossa fama tra i cultori
del genere e che tutto sommato riesce a mantenere le sue alte promesse. Il trio
è il veicolo musicale dello sfrenato chitarrista Jim Gustafson, fricchettone
biondissimo e occhialuto, di magnetica presenza, a metà tra un Johnny Winter in
salute e il guru hippy che Dean Stockwell impersonava in Psych-Out. Il terzetto
si assesta senza esitazioni tra i Pink Fairies di What A Bunch Of Sweeties e
altri gloriosi rocker sotterranei come Truth and Janey.
Nel caso in cui dopo il bailamme della canzone d’apertura vi trovaste
a guardare con sospetto le chitarre acustiche di Enjoy What You Have non abbiate troppa paura, perché il pezzo vanta
solidissime basi di unplugged indie alla prima maniera di Crazy Horse senza
spina, nonché un refrain dalla subdola orecchiabilità, pur in un’estetica di
modesto francescanesimo West-Coast. Che non dura, perchè con Live To Work si torna nel regno dell’ultra-boogie,
con johnnywinterismi beceri che vengono a galla come un cadavere pieno di birra
nella piscina gonfiabile dei bambini, un testo balordo (I’m such a jerk, i live to work!) e un un riff talmente liso che
può ben tener testa ad ogni gruppo garage in qualunque Bike-Fest tra Austin e Jacksonville.
Già nel ‘72 sembrava impossibile tirarci fuori l’ennesima canzone. Ancora più rozzo
Rock'n Roll, pezzo che lo stesso
Malcolm Young avrebbe avuto dubbi a mettere su disco e che ogni gruppo tra
Flint e Detroit avrebbe schifato, ma che nelle mani di Gustafson, per qualche strana
alchimia, riesce a trovare un proprio senso trash. Sarà che nel mezzo ci stava
il bizzarro psycho-flamengo di Bowleen,
un thriller che stupisce per la presenza sinistra di un organo atmosferico e
sibilante, minimalista si direbbe, che non tracima mai in una improvvisata jam
degna della fama più sinistra della Family di Manson. E peccato che il trio
sprechi metà dell’ultimo pezzo, Let me In,
con l’immancabile drum solo di Glenn Wiseman, che non riempie nessun vuoto
perché il gruppo, come gli inediti sulle ristampe CD ampiamente dimostrano,
aveva idee da vendere, e già qui la chitarra puramente hard di Gustafson lascia
intravedere assoli a cappella che si dilungano tra Farner e Angus Young in
bello spolvero. Accompagnò l’uscita del LP il singolo (Going to) Rock City, puro Motor-City-Hard-Rock tra Frost e MC5
depoliticizzati; poi si dovranno attendere anni prima della seconda uscita
ufficiale della band.
Il vinile, illustrato dalla peggiore illustrazione di Robert Crumb,
uscì in sordina per la Peppermint (etichetta bianco-nera) ed è oggi valutato
R3; non meno di 200 $ per una copia decente.
Molto interessanti le ristampe in CD, soprattutto quella del 2010 a
cura della Ripple che alle sei canzoni del vinile aggiunge addirittura 12 tracce
tratte da demo, live ed inediti: fondo del barile? Forse, ma alcuni pezzi sono
notevoli, tra schitarrate furenti ed ampiamente sottoprodotte, contrabbassi
saturi come campanoni di piombo e batterie scatenate in jam hard-psych senza
controllo (le lunghe tirate di Make A Man
Outta You, Upside Down Highway o
la demente I'm Crazy, You're Crazy). 9
euro (più spedizione) su Amazon.de, stessi prezzi (salvo aste fortunate..) su e-Bay.
***
Artista: Josefus
Titolo: Dead Man
Anno: 1970
Label: Hookah (330)
Line Up:
Pete Bailey: vocals,
harp
Dave Mitchell: guitar
Doug Tull: drums
Ray Turner: bass
Tracklist:
Crazy Man 4:00
I Need A Woman 4:20
Gimme Shelter 4:05
Country Boy 3:15
Proposition 4:45
Situation 1:55
Dead Man 17:30
Questo potrebbe essere il vero manifesto di tutto il folle Hard Rock
sotterraneo Americano: anno 1970 (perfetto), Texas Profondo (ottimo), un
chitarrista con tentazioni epiche, un sano e strafottente cantante, di quelli
che si strusciano continuamente l’asta del microfono tra le gambe; e un
batterista che pare Lemmy in versione Hell’s Angel imbarcato per caso sulla
prima nave pirata ad est di Sumatra. Poi un titolo inquietante e perfino una
copertina vagamente horror. Volete dell’altro? E allora beccatevi quei riff di
basso ipocentrici nella redenzione stoner di Gimme Shelter, oppure il frammento heavy-western per tramonti di
armonica e chitarra filtrata di Situation.
Ma certo ancora non vi basta, vero? Crazy
Man aveva aperto addirittura con riff sitareggianti da Deccan settentrionale,
che trascrivono Hendrix per branchi di Australopitechi sottoculturati fatti di
Mandrax; poi un hard-rock-dixie
classico in I Need A Woman:
Steppenwolf, Mountain, Zeppelin, soggiogati da una sezione ritmica cupa e
plumbea come poche, mentre la chitarra divaga senza cognizione tra riff
arcinoti e assoli ai saldi dei Cream. Proposition
è meglio ancora: il mercato nero delle chitarre hard attorcigliate a due note immutabili
di basso alla Mel Schacher, con interludio di minime sovraincisioni e
paleolitici effetti che sfigurano una Midnight
Rambler sotto luci speleologiche come in un graffito rupestre.
Non male, eh? Ebbene tutto quanto avete ascoltato fin’ora scordatelo;
perché adesso arriva “Il Brano”, quello che ha catalizzato le smanie di tanti
collezionisti e cultori dell’oscuro: Dead
Man. Mosso dalla stessa incostante ispirazione degli UFO di Mick Bolton, ha
il pregio di rinunciare all’esplorazione di Cygnus X-1 (cazzi dei Rush!) per
tuffarsi in un mondo sotterraneo e misterico, scoperchiando sarcofagi di mummie
azteche dimenticate negli antri catacombali di una mente deviata dall’ultima
pasticca di LSD del Texas. Diciassette-minuti-e-mezzo di danza Apache che
presta il fianco ad ogni possibile cinismo ma riesce, incredibilmente vista la
scarsa ispirazione, a tenere alti ritmo e tensione nell’ascoltatore; sarà per
via di quel timbro così nero, o del magnetico giro di basso; o magari, perché
no, della teatrale declamazione vocale di Pete Bailey, mentre la presunzione
epica di Dave Mitchell degenera in un soliloquio in bassa fedeltà, delirante ed
imprevedibile. Ci si risveglia sotto le sue frustate attorno al minuto
quattordici: come vola il tempo eh? E nonostante lo stordimento a questo punto
chiunque vorrebbe essere quel bassista
che sta ancora imperterrito sul suo du-du-du-doom
dum-dum/du-du-du-doom dum-dum. Mitchell fa a in tempo anche a chiudere su
una travisazione di How Many More Times,
che a sua volta travisava a destra e manca da Beck’s Bolero a The Hunter.
Ricominciate a respirare, perché si torna a vedere la luce alla fine del
tunnel. Benvenuti dentro le teste buie dei Josefus.
I Josefus sono stati una delle prime “riscoperte” di Rock duro
primordiale, se non che, furono inizialmente additati come ultimi discendenti
della scena psichedelica Texana della International Artist (The 13th Floor
Elevators, Red Krayola…) con cui in realtà ebbero poco a che fare. Ad ogni modo
finirono anche sulla vecchia “Enciclopedia del Rock Psichedelico” della Arcana
e questa ambigua fama lisergica non fece altro che accrescerne il culto.
Le vicende discografiche del gruppo sono piuttosto intricate, tra
cambi di etichetta e molto materiale inedito e più volte riemerso in anni
recenti. Il vinile originale della Hookah (etichetta giallo ocra-bianca)
viaggia ormai stabilmente oltre i 500 $, con punte addirittura vicine ai 1000$:
è sicuramente uno dei grandi pezzi da collezione nel suo genere; occhio a
prezzi più convenienti (comunque attorno ai 200$...) perchè facilmente
nascondono qualche pecca sonora.
Reperibili varie edizioni in CD (Soundazed e Akarma) con svariate
bonus ma non sempre a buon mercato su Amazon (20-25 $): meglio scandagliare
E-Bay per risparmiare qualcosa. Esiste anche una edizione Red Fox che abbina in
un unico CD i due album ufficiali del gruppo (circa 11 € su Amazon.de). C’è poi
Get Off My Case, di fatto un alternate mix di Dead Man, reperibile tanto in
vinile (con un bel booklet allegato) quanto in CD. A voi la scelta!
***
Artista: Alamo
Titolo: Alamo
Anno: 1970
Label: Atlantic (SD
8279)
Line up:
Larry Davis: bass
Larry Raspberry: vocals,
guitar
Richard Rosebrough: drums
Ken Woodley: keyboards,
voclas
A1 Got To
Find Another Way 5:10
A2 Soft
And Gentle 7:05
A3 The
World We Seek 3:40
A4 Question Raised 4:08
B1 Bensome Changes 3:37
B2 All
New People 4:53
B3 Get
The Feelin' 6:06
B4 Happiness Is Free 4:22
Sveglia, amici del sound vintage più educato e rispettoso delle onde
“Classic-Rock-FM”! Alamo è l’album che state cercando. Quartetto di discreti
capelloni di Memphis che, nel nome di un luogo in cui si formò lo US Pride, si arrende ai maestri inglesi
inzuppando tutto un LP in buon bourbon deepurpoliano (anche in versione Rainbow,
ancora ben lontani dal venire); ma al party ci sono anche Quatermass e Spooky
Tooth, senza dimenticare prodi conterranei come i Grand Funk (periodo Craig
Frost) o commilitoni confederati come i Bloodrock, sarà per l’appeal southern
della voce di Ken Woodley che ricorda assai Jim Rutledge, mancando sì della
tamarraggine e del gusto un po’ horror di Timepiece
o Double Cross, anche se All New People non scherza, ma sfornando
comunque un lavoro ben arrangiato, con un organo a tratti elegante da piccola parrocchia del
Sud, che spesso duetta con una chitarrona solista di stampo JeffBeck-iano e
insieme mantengono un equilibrio talmente saldo che alla fine sembra quasi (quasi
eh!) noioso: nessun eccesso, nessun colpo di testa, nessun palloso assolo di
batteria; chissà che la produzione dell’enorme Atlantic non abbia un po’
tarpato le ali a questo gruppo che, pur saldamente “riff-based”, manca del
pezzo fortissimo da lanciare su 45 giri. E se la lenta Soft and Gentle (…brrrr…) vi spaventa con quell’inizio soffuso e
sdolcinato, abbandonatevi tranquilli al bell’assolone da guitar hero solitario
di Raspberry e alla lunga risposta di coda dell’Hammond di Woodley (leader ed
autore di tutti i pezzi, fra l’altro), anche perché le quattro-canzoni-quattro
che seguono sono rampanti numeri hard, assai simili tra loro fino al punto di
mimetizzarsi l’una nell’altra, ma piacevoli all’ascolto, come una sigaretta
dopo il sesso. Appunti casuali: il riffone di The World We Seek (eccoli i Quatermass!) che parte dall’organo e
contagia chitarra e batteria, gli infuocati tappeti tastieristici in Question Raised, il prepotente groove
nel mezzo di All New People, dove la
band finalmente si abbandona a quell’enorme e sudata tamarreide ritmica che gli
appartiene di diritto ma che non sempre riesce a esternare completamente, pur se
già era emersa nella tremenda intro di Got
To Find Another Way, uno di quei pazzi per cui sbatteresti la testa contro
un muro finchè ce n’è…
Get the feelin’ scatena un
voltaggio imponente su una ritmica “samba-sabbah” tra Santana e il Frank Marino
di Satisfy Your Soul; Happiness Is Free (allarme hippy attivo!
- allarme hippy attivo!) rimbomba come una tempesta in un bicchiere, sbattendo
forte la sua grossa fronte heavy-pop contro una bella arrampicata libera per
schitarrate grezze. Alla fine non ricorderete il titolo di nessuna canzone ma, per
le vostre orecchie in cerca di anticaglie da rispolverare, il piacere è
puramente timbrico. E mi raccomando di alzare tanto il volume perché il sound
ne guadagna non poco, in questo disco bello da ascoltare se già di buon umore,
mentre in caso contrario non riuscirà a risollevarvi del tutto la giornata.
Classica etichetta (e classica inner) Atlantic “rosso-verde” e quindi
prezzi non impossibili per la stampa USA originale: buone copie per non più di
30 – 35 euro: può anche valerne la pena, visto anche il bell’acquerello di
copertina. Ristampato in CD dalla Black Rose (BR 138): nessun booklet, nessun bonus,
minime informazioni ma prezzi convenienti soprattutto su Amazon.de, 5 € nuovo
solo 3,5 € usato! Cosa aspettate?
***
Artista: Ursa Major
Titolo: Ursa Major
Anno: 1972
Label: RCA (LSP-4777)
Line Up:
Greg Arama: bass
Ricky Mangone: drums,
vocals
Dick Wagner: guitar,
vocals
Tracklist:
A1 Sinner 7:29
A2 In My Darkest Hour
5:26
A3 Silverspoon 6:14
B1 Stage Door Queen 5:26
B2 Back To The Land 6:47
B3 Lay Me Down 4:35
B4 Liberty And
Justice 5:51
Seri pretendenti ad una medaglia nella categoria dei supermassimi, gli
Ursa Major sono il competente terzetto di Dick Wagner (già coi Frost, poi con
Lou Reed e Alice Cooper) titolare di un solo LP dal titolo omonimo, fuoriuscito
dallo stesso Michigan di Amboy Dukes e Frijid Pink, ma che ha poco a che
spartire con la foga proto-punk di Detroit. Un lavoro di quelli potenti e
pomposi: sette tracce, tutti mid-tempo assai lunghi (oltre 40 minuti di album),
costruiti su Toniommismi (la proprietà del termine e di Julian Cope) doom e
rimbombanti come una campana di bronzo nell’antro di una cattedrale, spogliati
però della nebbiosa paranoia religiosa albionica in favore di uno sfacciato
ottimismo paramelodico tutto yankee; un po’ Kansas, un po’ REO Speedwagon
costretti ad esibirsi al Gods of Metal.
Per cominciare c’è l’eterna ouverture strumentale di Sinner che ammucchia riff su riff come
una cover band dei Black Sabbath che le prova tutte per copiare 2112 dei Rush;
poi Wagner si dimostra cantante con discrete smanie urlatrici, che avrebbe
potuto ben figurare in qualunque gruppo NWOBHM tra il 1982 e il 1984. La
tediosa In My Darkest Hour è
l’obbligatorio numero acustico e melenso, ma per fortuna arriva subito il “RiffdellaMadonna” con Silverspoon, brano che sembra uscito dal
lato A di Captain Beyond ed è mortificato solo da un imbarazzante pubblico
sintetico, finto-live, come neanche nelle sit-com del 1978. Causa questo crollo
di stile, il pezzo forte diventa Back To
The Land una power ballad molto power, mediamente ballad, aperta da un
motivo sinistro e quasi arabeggiante, con un filo di mellotron non fuoriposto, che
appena prima di deragliare nella Valle della Noia sforna un gran riff alla Foxy Lady ed un assolone effettato che
sarebbe piaciuto a Slash: un brano che può ben vantare discendenze importanti
tra l’AOR più allineato di fine decennio. Puro yankeehardrock in Lay Me Down
(meglio quella dei REO, ma solo il titolo è uguale…) mentre chiude Liberty And Justice, numero fintante
soft che dopo un paio di strofe acustiche esplode con l’attacco roboante della
batteria (ma guarda te che originale!); e se dopo il primo verso (when i was just a boy with my history books
and my christmas toys…) vi viene un attacco di diabete, nervi saldi: il
peggio deve arrivare. Evviva!
Alla fine della battaglia ciò che resta è un sound notevole, quasi
monumentale in certi momenti (vedi le bordate chitarristiche di Stage Door Queen), un album ben prodotto,
che si dilunga un po’ troppo su ginnastiche hard senza tanto costrutto.
CD abbastanza a buon mercato su Amazon: 8 $ in USA, 8 euro (con spese
di spedizioni un po’minori) in Germania, Inghilterra e Italia, addirittura 7,50
in Francia. Difficile trovare a meno su e-Bay a meno che non si viri
sull’usato.
Vinile non rarissimo ma scambiato a prezzi un po’ esagerati per il
reale valore dell’album, e comunque consigliato ai soli Wagneriani: non meno di
70-80 $ per una buona stampa americana, 40-50 euro per la versione tedesca. A
meno di non imbattersi in qualche affare, (c’è sempre qualche VG, tutto da
testare, a 20-30 euro) se siete curiosi buttatevi sul CD.
***
Artista: Alamo
Titolo: Alamo
Anno: 1970
Label: Atlantic (SD 8279)
Line up:
Larry Davis: bass
Larry Raspberry: vocals,
guitar
Richard Rosebrough: drums
Ken Woodley: keyboards,
voclas
A1 Got To
Find Another Way 5:10
A2 Soft
And Gentle 7:05
A3 The
World We Seek 3:40
A4 Question Raised 4:08
B1 Bensome Changes 3:37
B2 All
New People 4:53
B3 Get
The Feelin' 6:06
B4 Happiness Is Free 4:22
Sveglia, amici del sound vintage più educato e rispettoso delle onde
“Classic-Rock-FM”! Alamo è l’album che state cercando. Quartetto di discreti
capelloni di Memphis che, nel nome di un luogo in cui si formò lo US Pride, si arrende ai maestri inglesi
inzuppando tutto un LP in buon bourbon deepurpoliano (anche in versione Rainbow,
ancora ben lontani dal venire); ma al party ci sono anche Quatermass e Spooky
Tooth, senza dimenticare prodi conterranei come i Grand Funk (periodo Craig
Frost) o commilitoni confederati come i Bloodrock, sarà per l’appeal southern
della voce di Ken Woodley che ricorda assai Jim Rutledge, mancando sì della
tamarraggine e del gusto un po’ horror di Timepiece
o Double Cross, anche se All New People non scherza, ma sfornando
comunque un lavoro ben arrangiato, con un organo a tratti elegante da piccola parrocchia del
Sud, che spesso duetta con una chitarrona solista di stampo JeffBeck-iano e
insieme mantengono un equilibrio talmente saldo che alla fine sembra quasi (quasi
eh!) noioso: nessun eccesso, nessun colpo di testa, nessun palloso assolo di
batteria; chissà che la produzione dell’enorme Atlantic non abbia un po’
tarpato le ali a questo gruppo che, pur saldamente “riff-based”, manca del
pezzo fortissimo da lanciare su 45 giri. E se la lenta Soft and Gentle (…brrrr…) vi spaventa con quell’inizio soffuso e
sdolcinato, abbandonatevi tranquilli al bell’assolone da guitar hero solitario
di Raspberry e alla lunga risposta di coda dell’Hammond di Woodley (leader ed
autore di tutti i pezzi, fra l’altro), anche perché le quattro-canzoni-quattro
che seguono sono rampanti numeri hard, assai simili tra loro fino al punto di
mimetizzarsi l’una nell’altra, ma piacevoli all’ascolto, come una sigaretta
dopo il sesso. Appunti casuali: il riffone di The World We Seek (eccoli i Quatermass!) che parte dall’organo e
contagia chitarra e batteria, gli infuocati tappeti tastieristici in Question Raised, il prepotente groove
nel mezzo di All New People, dove la
band finalmente si abbandona a quell’enorme e sudata tamarreide ritmica che gli
appartiene di diritto ma che non sempre riesce a esternare completamente, pur se
già era emersa nella tremenda intro di Got
To Find Another Way, uno di quei pazzi per cui sbatteresti la testa contro
un muro finchè ce n’è…
Get the feelin’ scatena un
voltaggio imponente su una ritmica “samba-sabbah” tra Santana e il Frank Marino
di Satisfy Your Soul; Happiness Is Free (allarme hippy attivo!
- allarme hippy attivo!) rimbomba come una tempesta in un bicchiere, sbattendo
forte la sua grossa fronte heavy-pop contro una bella arrampicata libera per
schitarrate grezze. Alla fine non ricorderete il titolo di nessuna canzone ma, per
le vostre orecchie in cerca di anticaglie da rispolverare, il piacere è
puramente timbrico. E mi raccomando di alzare tanto il volume perché il sound
ne guadagna non poco, in questo disco bello da ascoltare se già di buon umore,
mentre in caso contrario non riuscirà a risollevarvi del tutto la giornata.
Classica etichetta (e classica inner) Atlantic “rosso-verde” e quindi
prezzi non impossibili per la stampa USA originale: buone copie per non più di
30 – 35 euro: può anche valerne la pena, visto anche il bell’acquerello di
copertina. Ristampato in CD dalla Black Rose (BR 138): nessun booklet, nessun bonus,
minime informazioni ma prezzi convenienti soprattutto su Amazon.de, 5 € nuovo
solo 3,5 € usato! Cosa aspettate?
***
Artista: Tongue
Titolo: Keep On Truckin' with Tongue
Anno: 1969
Label: Hemisphere
(HIS-101)
Line Up:
Bob Collins: bass,
vocals
Mick Larson: organ,
vocals
Paul Rabbit: guitars,
vocals
Dick Weber: drums,
vocals
Tracklist:
A1 Homely Man Blues
A2 Get Your Shit
Together
A3 The Earth Song
A4 The Prophet
A5 Sidewalk
Celebration
A6 Slap Her Down
Again, Paw
B1 Every Time
B2 Get Down
B3 Morning Dew
B4 Jazz On The Rag
B5 Keep On Truckin'
B6 Hashish
*Stained Glass Window
*Hey Hey Moma
* Bonus tracks (CD)
I Tongue sono un misterioso quartetto del Wisconsin che rappresenta la
quintessenza del sound on the road
destinato a pub e roadhouse ai limiti del Gran Canyon. Eterna spalla della
rockstar di turno, pubblicarono precocemente questo Keep On Truckin' (1969),
che ancora risente assai di influenze tremendamente “sixties” ma che pur offre
un bellissimo suono caldo di chitarra e Hammond, reminiscente di Steppenwolf,
Iron Butterfly e nei passaggi blues perfino degli ultimi Doors: una sorta di piccoli
Spooky Tooth made in U.S.A.
LP imponente, 12 pezzi (troppi!), quaranta minuti di musica, spazza
tutto il repertorio che il gruppo aveva messo a fuoco nei primi due anni
d’attività (rigorosamente dal vivo).
Si va dalle dodici battute di Homely
Man Blues, che mischia Animals e Morrison Motel e si lascia docilmente
dominare dall’organo di Mick Larson, ad una Get
Your Shit Together palesemente derivata dal Doug Ingle del primo LP degli Iron
Butterfly. Terza arriva la tirata più epica del disco, Earth Song, sette minuti belli pesanti, tra acido e metallo, senza
tanta logica ma con qualche bel fuzz nel mezzo ed una lunga e sinistra coda
sussurrata nella penombra delle tastiere. The
Prophet continua su questa sponda simil-progressiva, ha tutta la maldestra magniloquenza
dei Bloodrock di “2”, recupera l’intro di Babe
i’m Gonna Leave You così come la interpretava Page, ma riesce ad affascinare
grazie a quel sound sempre così vintage, come un velluto morbido e rovente allo
stesso tempo. Sidewalk Celebration si
abbandona, con qualche resistenza, al boogie-blues del primo John Kay, mentre
la poco ispirata Every Time dispiega
almeno un assolo di Rabbit alla ricerca di eroismi a buon mercato. Non male
l’hard-riff di Get Down, di nuovo in
scia agli Iron Butterfly, inchiodata ad un basso che spinge forte e ai
singhiozzi dell’hammond. Il secondo momento epico sono i setteminutiemezzo della celebre e abusata Morning Dew di Tim Rose, che dopo le cover di Jeff Beck e Jerry
Garcia divenne una sorta di standard nei primi anni ’70. I Tongue scelgono la
via zuccherosa del folk romantico, un po’ Youngbloods un po’ Thank You degli Zeppelin, se non fosse
per la vocalità fin troppo impostata che degenera addirittura in parodia lirica;
certo che sette minuti sono lunghi, c’è sempre il tempo di cambiare idea e
grazie al cielo il gruppo si concede qualche piccolo dinamismo in crescendo, sufficiente
almeno a non far sprofondare il pezzo nella Valle della Noia. Peccato, perché
la strada giusta sarà quella dell’iper-boogie dei Nazareth, un paio d’anni dopo.
Superati di slancio i Canned Heat-ismi retrò di Jazz on the rag, ecco il brano manifesto del gruppo, Keep on Truckin’ che di li a poco
diventerà cavallo di battaglia di un appassionato antiquario come Jorma
Kaukonen e che i Tongue rendono con simpatica semplicità country-blues.
Chiudono i “4-secondi-4” di Hashish…mah…
La ristampa CD (Gear Fab GF-151, 2000)aggiunge due tracce: la bella Stained Glass Window, con chitarrismi
distorti e organo alla Jon Lord, e l’hard rock motociclistico di Hey Hey Moma. 12 $ su Amazon.com, prezzi
un po’ più convenienti su e-Bay ma occhio alla Amazon tedesca che offre copie
usate a soli 7 euro.
Vinile di casa Hemisphere (etichetta nera a caratteri rossi) piuttosto
raro, con volume di scambi ridottissimo in rete, ma prezzo non proibitivo: una
buona copia si trova tra i 50 e i 60$, inutile spendere di più per un album che
certo non è un capolavoro… Bella comunque la foto di copertina con capigliature
afro allucinanti e jeans zebrati a zampa: veramente datati ma notevoli!
***
Artista: Demian
Titolo: Demian
Anno: 1971
Label: ABC (5718)
Line Up:
Roy Cox: bass, vocals
David Fore: drums
Rod Prince: guitar, vocals
Todd Potter: guitar,
vocals
Tracklist:
A1 Face The Crowd
2:35
A2 Windy City 5:18
A3 Love People 2:49
A4 Coming 5:30
B1 Todd's Tune 3:19
B2 No More Tenderness
3:50
B3 Are You With Me
Baby 4:54
B4 Only A Loner 4:35
Un classico quartetto con chitarre gemelle, non tanto conosciuto ma forte
di un’ ottima reputazione tra gli iniziati. Band originaria del Texas, ma
presto traslocata in California, formata sulle ceneri dei Bubble Puppy e prodotta
dal biondo bassista degli Steppenwolf Nick St. Nicholas, con una discrete
potenzialità FM pur se di fatto l’album è un “live in studio”.
Gruppo assai affiatato, dal dinamismo impeccabile e carica ritmica
notevole, dispiega un bel potenziale elettrico, come degli AC/DC
post-psichedelici e intontiti dal THC, ma sempre capaci di un senso
dell’equilibrio impressionante per il periodo: canzoni sintetiche, che non
degenerano mai in estenuanti esercizi di ginnastica chitarristica, sempre
ancorate a riff solidissimi, antisismici e dal forte sapore power-pop, imbastarditi
con degli Steppenwolf che suonano southern in lungo e in largo per le stesse
autostrade degli Allman Bros, con molta meno perizia tecnica, ma col notevole
graffio chitarristico di certi Quicksilver (Face
the Crowd). I cinque minuti di rock notturno in Windy City filano via lisci con una buona dose di classe, appena
laid-back negli assoli. Poi c’è il pezzo forte: l’hardrockkissimo Coming, riff duro che si incastra tra le
due chitarre e linea vocale bella tosta; nel mezzo, assolo di basso da eroe del
funk con tanto di fantastico duello call & reponse di Prince e Potter, per
nulla scontato e già in zona Gemelli Malvagi degli Eagles. D’obbligo qualche
numero più soft come il docile unplugged dagli occhi assonnati Love People, oppure il power-pop in bello stile Paul Kossof
di Todd's Tune, che torna a ruggire nel
bel crescendo finale, lasciando campo ad un assolo eroico di una linearità
spudorata. No More Tenderness
riprende l’atmosfera seminotturna sotto neon di tarda estate già sentita in Windy City e si abbandona ad un esteso
assolo non privo di feeling; poi certo che se il gruppo va un po’ giù di giri
con Are You with Me, Baby? il sound
si appiattisce e manca elettricità …ma parchè criticare questi ottimi
artigiani, forse fin troppo consci dei loro limiti ma pur in grado di sfornare
la migliore prestazione possibile per le loro capacità? Riascoltarsi 3 o 4
volte la bella Only a Loner per
ritrovare lo sprint giusto in un blitz hard rock che viaggia come un Harley tra
Los Angeles e Las Vegas, sulla coda di un epica schitarrata incrociata di
Potter e Prince.
Bella la copertina, ipersatura, a colori invertiti, con capigliature
afro, ciocche fluenti, barbe appuntite, espressioni vagamente strafatte e carta
da parati floreale.
La ristampa CD di casa Fallout è abbordabile anche su Amazon Italia
(circa 17 euro usato, una ventina nuovo) ma certo su E-Bay si può spuntare
qualche euro e comprare la versione BOD
Records del 2008 che unisce all’album dei Demian quello dei Bubble Puppy per un
costo totale tra i 13 e i 15 euro. Esistono anche una stampa in CD tedesca
della TRC e una della Green Tree, molto conveniente su Amazon.de (10 euro).
Per il vinile preparatevi a non spendere meno di 80-90 $, sono
parecchie le copie che superano i 100 ma sono anche parecchie quelle scambiate,
quindi l’affare è fattibile. Un po’ di risparmio con la stampa canadese.
***
Artista: Titus Oates
Titolo: Jungle Lady
Anno: 1974
Label: Lips (L 004)
Line Up:
Bill Beaudet: keyboards
Chris Eigenmann: percussion
Rick Jackson: bass, vocals
Lou Tielli: guitar
Steve Todd: guitar
Tracklist:
Jungle Lady 3:16
Dream On A Train 4:07
Blanket 3:33
Friend Of Life 3:49
Jupiter, Mars 3:55
Time Is Only To Fear 3:43
Mr. Tips 3:46
Don't Get Your Honey Where You Make Your Money 4:45
The Cage 7/2/74 4:05
Sembra quasi di vederli, questi damerini di Dallas aggirarsi per i clubs di downtown alla ricerca della ragazza giusta a cui fare ammirare il panorama dalla città al tramonto da dietro un parabrezza parcheggiato sulla collina. Un integerrimo ma poco coraggioso album di pop-soul metropolitano, assai levigato nel suono di tastiere e chitarre wha-wha che storpiano il funk di Harlem sotto il verbo di Santana e finiscono a tratti per essere una versione melodica dei tardi War. Chi teme attacchi di diabete stia alla larga dai mellotron alla Berry White di Dream on a Train, clamoroso soft-rock per adolescenti in amore a cui brillano gli occhi e la cui mielosa melodia rischia di appiccicarsi alle orecchie; stessa roba nel country patinatissimo di Time Is Only to Fear (appena più sognante, con tanto di voce femminile) e Friends of Life, proto AOR, dopotutto piuttosto ben prodotto e con una discreta dose di sinistra suspense. Ben risolto il rock-pop (di britannico stampo) per hammond a lieto fine di Jupiter, Mars e alla fine c’è spazio anche per un riff concretamente hardrockeggainte in Mr. Tips, svilita appena dalla tastiera, ma decisamente non male. Va a finire che uno dei brani migliori è il funk atmosferico Listen Now! Don't Get Your Honey Where You Make Your Money, sound assolutamente urbano (in zona Stamp Album della Climax Blus Band), illuminato da neon blu e fucsia e da soffuse liquidità chitarristiche da cocktail lounge ben alternate ad accordi battenti. Ma in realtà anche il riff finto-celtico-irlandese su Jungle Lady lascia un bel sapore in bocca, così come le eroiche sgroppate di basso su Blanket, pezzo efficace tanto nella strofa quanto nel ritornello e nel bel duetto per chitarre contrapposte che sarebbe potuto durare oltre dieci minuti e invece viene mortificato da un ottuso fade-out. Poi The Cage 7/2/74, una auto-cover di Jungle Lady, che finisce per chiudere il cerchio con la traccia d’apertura, con un nuovo duello tra Bill Beaudet e la coppia Tielli-Todd.
Controindicato ai fanatici di Grand Funk o Sir Lord Baltimore, più adatto ai pochi estimatori dei momenti più melodici di Kansas e Styx.
Vinile (Lips L 004, etichetta rossa; esistono anche copie demo precedenti con mix leggermente diverso) di rarità pare in quantificabile: Joyson lo qualifica come R3 ma scordatevi una copia originale sotto i 150 $ anche perché quelle di qualità migliore stanno tra i 200 $ e i 300$! Assolutamente non ne vale la pena! Da segnalare l’esistenza di una ristampa su vinile del 1988 (Hab label HBL 11006)
Il CD della Radioactive si porta a casa con circa 9 euro più spedizione su Amazon.de e .co.uk, prezzi un po’ più alti in America e Italia.
***
Artista: Maypole
Titolo: Maypole
Anno: 1970
Label: Colossus (CS-1007)
Line Up:
Steve Mace: guitar
John Nickels: bass
Dennis Tobell: lead guitar,
backing vocals
Kenny Ross: lead vocals
Paul Welsh: drums
Tracklist:
Glance At The Past 10:05
Show Me The Way
Henry Stared
Changes Places 9:26
Under A Wave
Look at Me
Johnny 4:25
Come Back 4:25
You Were 2:52
In The Beginning 4:37
Dozy World 3:05
Stand Alone 7:12
Un album di quelli enormi (cinquanta minuti!), per questi chitarristi
maratoneti di Baltimora che fanno del barrage ritmico tra Townshend e McGuinn
un annacquato marchio di fabbrica per costruirci sopra un lato A fatto di due
estese suite di 10 minuti l’una,
divise ognuna in tre “movimenti”. Sentori progressivi? Neanche per sogno:
nessun cambio di ritmo, nessuna tastiera, nessun flauto, neanche un cantante castrato
… solo voltaggi chitarristici notevoli e un’ ispirazione di songwriting che
guarda inaspettatamente ai Kinks di Face to Face (Show Me The Way) e ancor più palesemente ai Byrds più epici,
deformati da una lente di sana megalomania, palese già nel concept, interpretato
dalle note di copertina come la ricerca di una rivoluzione culturale pari a
quella che nel villaggio di Merrymouth, nel XVII secolo, spezzò le rigidità
delle leggi puritane… Così, tanto per complicarsi la vita… Tra suoni solo vagamente sudisti e facili
melodie assolate e biecamente “christian rock”, che piacerebbero ai Kings of Leon,
Henry Stared è sognante come il monologo
di qualche capellone californiano in tremendo ritardo all’ultimo live dei Wishbone
Ash, quelli delle parti più lente di Argus. La seconda suite, composta dal
trittico Changes Places/Under A
Wave/Johnny è, grazie al cielo, più energica, mossa da riff battenti come una
James Gang filtrata da un bel setaccio funky, mentre il cantante Kenny Ross si
sforza di trovare il giusto timbro tra una finta innocenza adolescenziale e un ammiccamento
dandy appena miagolante, riuscendo, in Changes
Places, ad indovinare anche un bel fraseggio moderno, se ritenete moderno
il brit-pop degli Oasis.
Il lato B è una sciarada di pezzi più sintetici (eccetto i sette
minuti e mezzo di Stand Alone)
costantemente costruiti su intrecci chitarristici assai power-pop, che nei
momenti più felici (ma solo lì…) potrebbero essere scarti dell’Alex Chilton dei
Big Star (Dozy World) con la solista
di un Neil Young appena adolescente (In
The Beginning). In chiusura la lunga Stand
Alone, che si apre con i soliti accordi da Stairway to Heaven, o Taurus…se
siete maligni (d’altronde siamo solo nel ’70…) e si dilunga su toni da ballad
depressa e pedante, riscattata solo parzialmente dall’ovvia coda strumentale finale.
Originariamente distribuito dalla Colossus, con label gialla e scritta
rossa, il vinile è oggi un piccolo pezzo da collezione, raro sì ma di qualità musicale
non eccelsa. Difficile trovare una copia in buono stato sotto i 70 $ anche se
ci sono in giro molti VG tra i 40 e i 60 $…per chi si fida. Non spendete più di
80$ comunque, perché la musica non ne vale la pena … La Radioactive ha
ristampato il CD nel 2006 e la Gear Fab nel 2010; prezzi altini se si acquista
direttamente su Amazon (poco oltre i 20 $) ma molti venditori affiliati offrono
il CD a circa 15 $; se si va sull’usato si possono poi spendere non più di 8-9 €
(più spedizione).
***
Artista: Mason
Titolo: Harbour
Anno: 1972
Label: Eleventh Hour (1001)
Line Up:
Steve Arcese: organ,
bass, vocals
Jim Galyon: bass, flute,
sax, guitar, vocals
Margan Hampton:
drums, vocals
Tracklist:
Let It Burn 4:30
Tell Me 7:15
Electric Sox And All
4:54
Golden Sails 3:05
Travelin' 4:13
Harbour 8:20
Goin Home 2:22
Charlotte 2:16
*Carry Me Home 3:49
*One More Drink :39
*bonus
Eclettismo ben sopra la media per
questo terzetto della Virginia organizzato attorno al poli-poli strumentista
Jim Galyon (chitarra, sax, flauto, occasionalmente pianoforte) ma dominato per
lunghi tratti dal suono dell’ Hammond di Steve Arcese, cupo, distorto ai limiti
del gotico truculento, una quinta scenica che conferisce un sentore di voodoo
negroide al soul già bollente del gruppo (Let
It Burn). Brani derivati da jam libere, e laddove l’improvvisazione si fa
più elastica e addirittura jazzata, il gruppo funkeggia su giri di basso e
organo dalla pelle bianca, come i migliori Climax Blues Band con l’aggiunta di
fiati alla Black Widow. Ma se nel bel mezzo di Electric Sox And All doveste risvegliarvi dall’incubo pensando di
essere da qualche parte tra Gentle Giant e Weather Report, niente paura:
abbandonatevi ai sette minuti di Tell Me,
heavy rock stracarico di cowbell da roadhouse, pulsioni di basso e strati
chitarristici in puro sound motociclistico marca Steppenwolf. Se non vi basta
c’è poi Travelin', stessa roba ma
ancora più martellante nel basso profondo e sabbathiano di Arcese. Per i
temerari seguono gli otto minuti e mezzo di Harbour,
landa crepusclare in cui è veramente difficile capire dove il gruppo vada a
parare, finché non ci rendiamo conto di essere nel mezzo di un depresso blues
esistenzialista e rallentato come il battito di un malato, in cui uno svogliato
Tim Buckley si presta alle saghe sociopatiche dei Van Der Graaf. Tra tanto cupo
torpore, la rilucente Golden Sails, Ian
Anderson che canta Tangerine con
CSN&Y, acquista ancora più risalto grazie ad un appiccicoso ritornello.
Nella stessa vena folk-prog anche l’elegia pastorale di Charlotte. Ce n’è per tutti!
La Gear Fab ha ristampato l’album in CD nel 1999, con tanto di 2 bonus
tracks ed esaurienti note di copertina (tra 8 e 10 $ su Amazon USA, prezzi un
po’più alti, ma con spese di spedizioni minori in UK). Più complessa la
situazione del LP originale, distribuito dalla piccola Eleventh Hour e
catalogabile come R2. Sono due le versioni che circolano: la primissima stampa
è una “private press”: in copertina la scritta MASON su cartoncino giallo
incollato sulla busta esterna bianca e label interamente gialla; una seconda versione
presenta la stessa copertina in bianco e nero che sarà poi del CD e label
nera/arancione.
Prezzi assolutamente incostanti; la stampa su label gialla, in
condizioni decenti (VG-VG+), si può anche avere per una quarantina di euro,
mentre le stampe migliori della variante nero/arancione superano spesso gli 80
$ e a volte anche i 100 $. Occhio alla qualità del disco se il prezzo appare
competitivo (20-30 Euro).
***
Artista: Highway Robbery
Titolo: For Love or Money
Anno: 1972
Label: RCA (LSP 4735)
Line Up:
Don Francisco: drums,
vocals
John Livingston
Tunison IV: bass, vocals
Michael Stevens:
guitar, vocals
Tracklist:
A1 Mystery Rider 3:03
A2 Fifteen 2:57
A3 All I Need (To
Have Is You) 4:19
A4 Lazy Woman 5:44
B1 Bells 3:24
B2 Ain´t Gonna Take
No More 3:56
B3 I´ll Do It All
Again 4:16
B4 Promotion Man 6:06
Questi Highway Robbery incarnano alla perfezione il formato del power-trio
isterico e fanatico dell’alta velocità, distinguendosi per un approccio
talmente trash e grezzo da far impallidire gli stessi Grand Funk. Valga
l’esempio di Promotion Man, ultima
enorme traccia, che vanta un riff staccato alla Free, con revolverate di slide
(già anticipate in Ain´t Gonna Take No
More) degne di un Johnny Winter zeppo d’anfetamina, talmente parossistiche
ed esagerate che il brano sembra una divertente parodia piuttosto che un pezzo
da prendere sul serio. Con Don Francisco che canta roba tipo “Ehi, signor DJ, perché non vuoi suonare il
mio disco? Ho bisogno di soldi!!! Voglio vivere a Hollywood!!” la demenzialità
è assicurata. Stesso discorso per il tentativo free-rock anti-femminista di Lazy Woman (tra Crossroad versione Cream e Heartbreaker),
brano supremo dell’album, con un eterno assolo di chitarra che nulla ha a che
vedere con la canzone in sé e che sfreccia invasato dal demone della Velocità,
come un Alvin Lee in versione speed-metal, tanto da diventare la soundtrack di
un B-Movie tipo “Il figlio di Van Halen
contro gli Slayer dell’oltrespazio”; nel finale Michael Stevens dispiega
una riffoteca che basterebbe per altri due album, un po’ come il Jimmy Page
nella coda di Out on the Tiles.
D’altronde il gruppo era stato chiaro sin dall’inizio con una coppia di brani, Mystery Rider (aperta da maree di wha-wha
ed effetti misti “a cappella”) e Fifteen,
brevi, incisivi come Communication Breakdown suonata dai Mothorhead di Bomber, con
un proto-Fast Eddie Clarke nell’ assolo finale dell’assalto hardcore della
seconda traccia e un batterista scatenato che scimmiotta maldestramente un
Keith Moon in forza ad una banda militare. Gli altri pezzi trovano una non
facile quadratura con ballatone lente e addirittura sinistre (Bells, I'll Do It All Again quest’ultima con un bel basso pulsante alla Dazed and Confused) da cui emergono
coretti come gli Who della primissima ora, sospettosi riff semiacustici ed improvvise
esplosioni hard.
Nessun trucco, nessuno strumento eccetto batteria-basso-chitarra, un
bassista dal nome improponibile in un gruppo di banditi come questi: andate
tranquilli!
La ristampa CD Collectables del 2000 assicura un prezzo abbastanza contenuto (tra 15 e 20 $ su
Amazon USA) mentre il fatto che il vinile fu distribuito dalla RCA fa si che la
valutazione delle stampe originali non sia oggi del tutto proibitiva: in media
tra 80 e 100 $ per una buona edizione americana, difficilmente sotto i 50 $ ma
non comprate per più di 100 $; piuttosto diffusa anche la stampa tedesca con
cui si può risparmiare qualcosa.












.jpg)







.jpg)
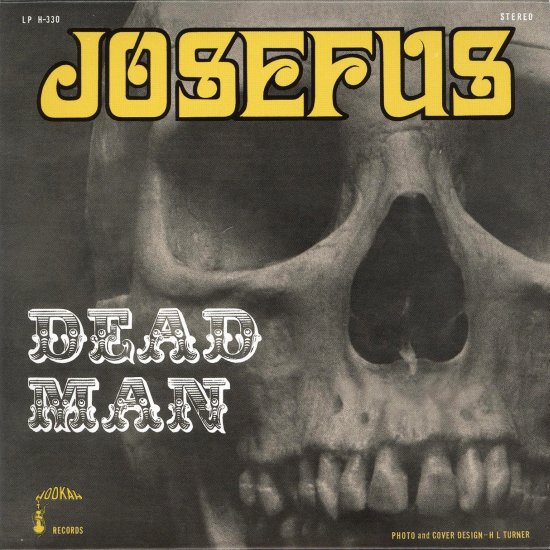



.jpg)





Nessun commento:
Posta un commento